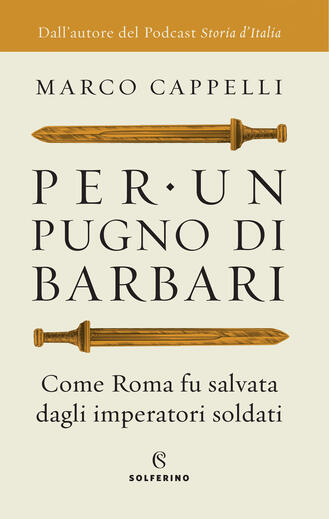
L’Impero romano è a pezzi, diviso in tre parti. I barbari saccheggiano impunemente le sue città e province, le pestilenze falcidiano la sua popolazione, l’inflazione galoppante distrugge la sua economia. Un imperatore debole siede nella sua capitale in Nord Italia, sempre più impotente di fronte alle tempeste della storia. Dei capi semibarbari sono pronti a rimpiazzarlo con un colpo di Stato militare. Il grande regno dei Cesari pare destinato al tramonto. L’anno non è però il 476 e questa non è la storia di come Roma cadde, ma di come seppe reagire al suo declino, e di come fu salvata da un gruppo di rozzi militari, gli imperatori illirici. Marco Cappelli, autore di uno dei podcast di storia più seguiti, racconta la grande parabola della discesa di Roma negli inferi della crisi del terzo secolo e della sua successiva, miracolosa rinascita sotto Aureliano e Diocleziano, tra battaglie e colpi di scena, grandi protagonisti e rivolgimenti sociali. Con grande verve narrativa e un resoconto dettagliato e avvincente, ci accompagna in uno dei periodi della storia romana tra i più affascinanti e meno conosciuti.
Editore: Solferino
Anno edizione: 2021
Pagine: 480
Formato: Brossura ed Ebook
Come Roma fu salvata dagli imperatori soldati
Per molti di voi il nome Marco Cappelli è già noto. Il creatore di uno dei podcast storici più famosi d’Italia non ha bisogno di presentazioni. Per chi volesse qualche informazione, invece, consiglio la bella intervista che lo stesso Marco ha rilasciato a Narrare di Storia.
Qui ci occupiamo della sua prima opera di saggistica. Per un pugno di barbari racconta le vicissitudini dell’impero romano da Marco Aurelio a Diocleziano. Il focus dell’esposizione è incentrato sulle vicende politico-militari
Da appassionato di storia romana e profondo conoscitore del periodo storico in esame, mi sono approcciato alla lettura con le seguenti due domande preliminari:
- Quale uso l’autore ha fatto delle fonti primarie e secondarie, “ingenuo” o “furbo”?
- Da divulgatore, quale tono “narrativo” l’autore ha dato all’opera?
Cosa intendo per uso delle fonti? La vicinanza temporale degli storici antichi non implica una loro maggiore affidabilità, anzi si è a volte dimostrato l’esatto contrario. Se l’autore avesse scritto il suo libro “pigramente” avrebbe potuto limitarsi a ricopiare ciò che le fonti antiche ci dicono. Considerando l’ingombrante presenza tra di esse della Historia Augusta, inesauribile fonte di aneddoti pittoreschi, l’autore avrebbe avuto gioco facile nel ricalcare questa e altre opere di maggiore spessore (come Cassio Dione).
Cappelli ha invece schivato il rischio ricorrendo, con abbondanza, alla moderna critica storiografica anche di lingua inglese. Farò un esempio su tutti: le fonti antiche sono concordi nel ritenere che l’assassinio di Commodo, il 31 dicembre del 192 d.C., fu un atto improvviso e la successiva elezione di Pertinace “casuale”; la critica moderna ritiene invece, considerando la comune origine del prefetto del pretorio Leto e di alcune nomine politiche, la mancata reazione dei governatori di province dotate di truppe e, in sostanza, la transizione “liscia” del potere, che vi fu un complotto premeditato. Del resto, ben diversa fu l’accoglienza che ricevette Didio Giuliano pochi mesi dopo, in seguito all’assassinio di Pertinace: l’immediata ribellione dei governatori di Siria, Pannonia e Britannia, cioè le province più militarizzate dell’impero. Questa è anche la versione che ci espone Cappelli.

Un altro esempio, che ritengo ancor più decisivo nel dimostrare che l’autore ha studiato è la decisione di far partire la narrazione dal regno di Marco Aurelio e non da quello di Commodo. L’opinione comune su questi due imperatori (rafforzata anche da un famoso film) non potrebbe essere più diversa: da un lato, il saggio imperatore filosofo; dall’altra il folle figlio gladiatore. Tuttavia, l’opinione comune per troppo tempo ha tenuto conto soltanto di ciò che gli storici antichi (di solito nostalgici senatori o borghesi ) ci dicevano. La realtà dei fatti è che il regno di Marco Aurelio e Lucio fu un continuo accavallarsi di disgrazie e disastri, guerre e pestilenze. Se qualcuno dovesse chiedermi: vorresti vivere al tempo di Marco Aurelio o di Commodo? Non esiterei ad indicare il secondo.
Cominciare la narrazione da Commodo (come fanno, per consuetudine più che scelta meditata, molte storie di Roma) avrebbe impedito di capire l’origine di moltissimi problemi che avrebbero poi afflitto l’impero nel III secolo: le invasioni barbariche da più fronti contemporaneamente, le usurpazioni improvvise, le pestilenze ricorrenti.
Passiamo alla seconda domanda. Per un pugno di barbari è un’opera divulgativa che, al contrario di una più “seriosa” opera storiografica, ha libertà di poter dare un tono narrativo alle vicende narrate. In questo caso l’autore ricorre da un lato a paragoni, mai forzati e mai banali, tra la storia contemporanea e quella antica; dall’altra, a citazioni della cultura pop, che danno un pizzico di sale allo stile. Ho trovato azzeccato soprattutto il paragone con cui il libro si apre: quello tra i generali sovietici che nell’agosto del 1991 tentarono un colpo di stato per restaurare l’Urss e i generali illirici che complottarono contro Gallieno nel 268.
Da un punto di vista più generale, la narrazione dell’autore è incentrata sul seguente filone: l’impero andò per diverse motiviazioni in crisi tra II e III secolo; venne salvato da un pugno di militari energici (da Claudio il Gotico a Diocleziano), preceduti da un notevole e bistrattato sovrano (Gallieno) che fecero “ciò che andava fatto” dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.

Ho detto fiscale e finanziario: uno dei punti di forza del libro, oltre all’esposizione delle vicende strettamente politiche e militari, è l’attenzione riservata all’andamento economico dell’impero. Cappelli segue in dettaglio le politiche monetarie degli imperatori, il principale strumento dell’antichità per intervenire sull’economia. Dalle monete “forti” degli ultimi antonini ai pezzi di rame e metalli impuri del III secolo, l’autore ha anche curato una utilissima tabella, aggiornata di capitolo in capitolo, che riporta la percentuale di metallo prezioso contenuta in ogni moneta. Diminuire il contenuto prezioso di una moneta permetteva di “coniarne” di più e quindi pagare più soldati; tuttavia ciò comportava una inflazione sempre crescente che divenne infine disastrosa per le attività economiche.
Il libro si chiude con il regno di Diocleziano e qualche cenno sulle vicende seguenti. Sono i capitoli più ispirati del libro. La descrizione delle riforme del grande imperatore è quanto mai precisa, chiara ed evocatica: da un impero amministrato in modo “amatoriale” Diocleziano creò una struttura burocratica possente che regolamentò, misurò e cambiò ogni cosa. Il racconto delle persecuzioni dei cristiani è impreziosito da documenti dell’epoca.

L’unico vero appunto che mi sento di fare all’autore è il non aver ampliato la visione sull’epoca: a parte un paio di citazioni, il lato culturale-archeologico trova poco spazio nel libro. Ed è un peccato perché, quando invece tale lato viene toccato, ci sono sempre spunti molti interessanti.
Al di là di questo, però, l’opera è assolutamente raccomandata. Alcune parti sono di assoluto valore, l’uso delle fonti è attento e perspicace. L’autore, come già detto, ha studiato!
Consigliato!
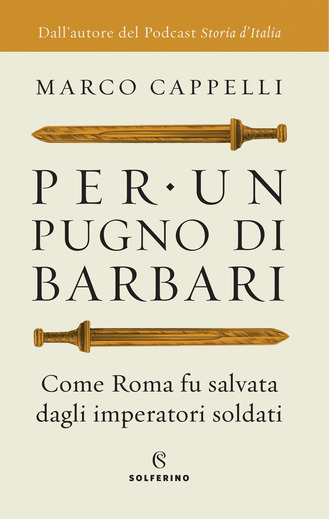
L’ha ripubblicato su Storia d'Italiae ha commentato:
Davvero un’ottima recensione del libro da parte di uno dei miei blogger preferiti!
"Mi piace"Piace a 1 persona