di Stefano Basilico
Ci sono date che nel corso della storia hanno la curiosa proprietà di ripetersi, proponendo nel corso delle diverse epoche avvenimenti – spesso, battaglie – epocali: nel senso che segnano il passaggio tra fasi e periodi nel dipanarsi delle vicende di nazioni e popoli.
Gli esempi potrebbero essere innumerevoli. A paradigma, potremmo citare in prima istanza il 2 agosto: in un itinerario che spazia dalla Battaglia di Canne (216 a. C.) a quella di Aboukir (1798) fino all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq (1990). Oppure, considerando il 2 settembre, si va dalla Battaglia di Azio (31 a.C.) a quella di Sedan (1870), fino al giorno dell’indipendenza del Vietnam e alla resa incondizionata del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, firmata a bordo della nave da battaglia USS Missouri, all’ancora nella Baia di Tokyo (entrambi nel 1945).
Per introdurre l’autore che compare nel titolo, vogliamo parlare del 9 agosto; una giornata che – in epoche distanti tra loro – ha segnato profondamente l’evoluzione della Storia di Roma, dalla fase republicana a quella del principato: da Farsalo, in Tessaglia (48 a.C.) a Adrianopoli, in Tracia (378 d.C.).
Andiamo con ordine.
La battaglia di Farsalo, come ben noto, ha rappresentato la chiave di volta della guerra civile tra Gneo Pompeo e Giulio Cesare. Un libro recente, edito nel 2018, di Sergio Valzania rappresenta una lettura molto interessante; per comprendere bene le ragioni di uno scontro che andava ben oltre l’ambito militare.

Un dissidio che nasce da lontano: già dalle lotte tra patrizi e plebei, tra Populares e Optimates, dalle riforme dei Gracchi e poi fino a Lucio Sergio Catilina. A Farsalo, sarebbe andato in scena virtualmente l’ultimo atto: da una parte Pompeo, un uomo “desideroso di essere il primo, ma incapace di essere l’unico” (secondo la magistrale definizione di Concetto Marchesi, il massimo latinista italiano); dall’altra Giulio Cesare, un uomo capace di far arrestare Tito Livio davanti ad un arcano insolubile, di fronte al quale la storia sembra essersi fermata.
Il grande storico patavino scrive della storia di Roma a partire dalle origini in un’epoca (quella di Ottaviano Augusto) in cui ormai il Principato è una realtà politica dalla quale non si può tornare indietro.
Con tutto ciò, Tito Livio ha ben chiaro il dilemma del percorso politico che dalla repubblica consolare e senatoria – passando per le guerre civili – ha portato al potere assoluto e all’impero; i 19 libri nei quali parlava di Giulio Cesare sono perduti, ma dopo averne narrate le gesta chiudeva la trattazione con un interrogativo al quale non sa dare una risposta: se la nascita di Cesare sia stata un bene o un male per lo Stato (“in incerto esse utrum illum nasci magis rei publicae profuerit an non nasci”, come riportato da Lucio Anneo Seneca in Nat. Quaest., V, 18, 4). Per inciso, i problemi dell’interpretazione del ruolo del “cesarismo” nell’evoluzione politica di una società – quali tratteggiati da Tito Livio – ci portano alle Note sul Machiavelli di A. Gramsci, nei Quaderni dal Carcere.
Ma torniamo a Sergio Valzania: autore mai banale. Come in altri casi, il racconto di una giornata – o di un avvenimento – è la chiave di ingresso per un’analisi molto più approfondita: quella dell’itinerario storico, politico e militare che vi ci ha condotto. Nel caso specifico, il percorso che arriva in Tessaglia parte già dalla riforma mariana dell’esercito, si snoda come detto attraverso i momenti che segnano una acuta crisi della Repubblica: dalla Guerra di Giugurta allo scontro tra le fazioni Mariana e Sillana; scontro che vedrà poi un’appendice in terra lusitana, nella campagna contro Sertorio: fino al fatale epilogo, da Durazzo a Farsalo.
Una lettura piacevole ed interessante, in uno stile sempre agile e mai paludato, che tuttavia propone al lettore un approfondimento ed analisi rigorosa di un periodo cruciale della Storia di Roma. Fino a quella battaglia: uno scontro quasi “assurdo”, se visto dalla parte pompeiana: perché in realtà Pompeo – discreto tattico ma rivelatosi complessivamente mediocre come stratega – la guerra contro Cesare sembrava forse sul punto di vincerla; aveva infatti condotto una accorta e prudente campagna di logoramento, che aveva messo in seria difficoltà il suo avversario, lontano dalle sue basi e con seri problema logistici e di rifornimenti: poi, la sconcertante, repentina decisione di dare battaglia (anche sotto la spinta dei suoi luogotenenti), fidando nella superiorità numerica. Ma le legioni di Giulio Cesare, in gran parte formate dai suoi fedelissimi veterani – reduci delle campagne vittoriose in Gallia, Britannia, Rezia e Norico – nelle pianure della Tessaglia diedero una volta di più la prova di tutto il loro valore, coesione e consumata disciplina.
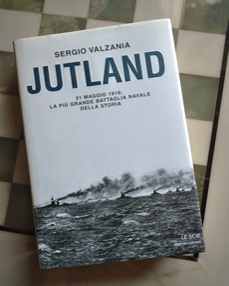
Leggere un libro, conoscere un autore. Il modus operandi di Valzania era già emerso, analogamente, in Jutland (2004): in questo caso, il racconto del colossale scontro tra la Grand Fleet di Jellicoe e Beatty e la Hochseeflotte di Scheer e Hipper era stato la chiave di ingresso per l’analisi della assurdità culturale, politica, militare ed economica del percorso che da Sedan ha condotto a Sarajevo; la fine dell’Europa, che aveva abdicato al suo primato planetario (a tutti i livelli: político, economico, militare, sociale) per mandare al massacro la sua “meglio gioventù”: nelle Fiandre e in Artois, in Masuria e in Galizia, a Gallipoli ed in Mesopotamia, sul Carso e sui Carpazi… (per inciso, ancora qualche anno fa ebbi la piacevole sorpresa di vedere esposto questo volume nella vetrina di una grande e centralissima libreria di Madrid, tradotto in castigliano: “Jutlandia”).
Sempre in tema di guerra navale, un altro libro molto interessante di Sergio Valzania è U-boot. Storie di uomini e di sommergibili nella Seconda Guerra Mondiale (2011). La humana pietas di fronte alla sorte dei 28.000 sommergibilisti tedeschi affondati con i loro battelli durante il conflitto, pur nella consapevolezza di numeri che possono scomparire di fronte ai milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale. L’analisi ed interpretazione della arma subacquea come paradigma – e trait d’union – tra le due guerre mondiale: conflitti che la storiografia più recente tende a riunire in un’unica “guerra civile europea” (1914-1945). Karl Dönitz, l’emblema di questa parabola storica e militare: da giovane tenente di vascello a futuro Großadmiral; dall’epoca di Weddigen, capace di silurare con il suo U-9 – nel giro di poche ore, e in pieno giorno – tre incrociatori corazzati inglesi nel Mare del Nord (22 settembre 1914) fino alla intuizione – ancora embrionale, e nel Mar Mediterraneo – di quella che sarebbe stata la ben nota tattica dell’attacco dei “branchi di lupi” (Wolfsrudeltaktik) in Oceano Atlantico, un paio di decenni più tardi.

E dopo che il Korvettenkapitän Gunther Prien, silurando nelle prime ore della notte del 14 ottobre 1939 con il suo U-47 la nave da battaglia HMS Royal Oak all’ancora a Scapa Flow aveva in qualche modo reso onore al sacrificio estremo della squadra da battaglia della Kaiserliche Marine, autoaffondatasi in quelle stesse acque il 21 giugno del 1919.
Ancora, un libro che è l’occasione per una riflessione sulla dinamica militare e política europea, con uno speciale focus sul ruolo della Germania: in quell’itinerario che va dalla Kultur di Kant, Fichte e Hegel a Sadowa e Sedan, da Tannenberg a Verdun, da Danzica alla resa del 8 maggio 1945. E poi – anche – fino al muro di Berlino, specchio di quella divisione che sembra richiamare un’intuizione antica, già presente nelle pagine di Cornelio Tacito, in quella monografía etnografica del 98 d.C. che non ha precedenti nella storia della letteratura antica:
Maneat, quaeso duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil jam praestare fortunamajus potest quam hostium discordiam.
E prego che così continuino quei popoli, se non per amor nostro, per odio fra di loro, dal momento che, ora che si profila un minaccioso destino sull’impero, la fortuna nulla può accordarci di meglio che la discordia fra i nemici.
De situ et origine Germanorum, XXXIII
Rimaniamo nell’ambito della storiografia antica: Valzania mai banale, si diceva. Ne fa fede una rilettura molto originale che proponeva qualche anno fa della Guerra del Peloponneso. Forse, poco più che una serie di baruffe da cortile, che ha però “avuto il merito” di essere consegnata all’eternità da una penna sapiente: quella di Tucidide, che non a caso già in premessa rivendicava il principio del κτῆμα ἐς αἰεί (un messaggio che dovesse rimanere per l’eternità).
Questo, un passaggio tratto dalla introduzione a Sparta e Atene (2011):
Quella del Peloponneso non fu una grande guerra. Venne combattuta da piccole comunità che si contendevano il controllo di un territorio non particolarmente fertile e commerci estesi, ma quantitativamente limitati. Una volta dissi ad un caro amico, che se ne intende veramente molto, che gli ateniesi erano ricchi. Mi rispose: «Mangiavano pane e olive». Eppure Tucidide ha saputo fare di questi trent’anni di conflitto il modello di tutte le guerre. Dopo il suo racconto ogni narrazione bellica ha dovuto confrontarsi con la sua. Giustamente è stato detto che la guerra del Peloponneso sarebbe stato un capolavoro della letteratura e dell’arte militare anche se Sparta e Atene non avessero mai combattuto per il controllo della Grecia, se si fosse trattato «semplicemente» del frutto della sua fantasia.
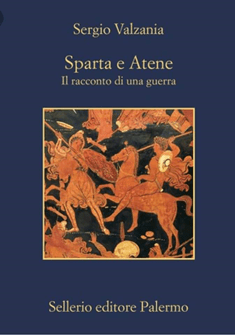
Questa lettura di Valzania – critica e graffiante – introduce al più vasto tema della storiografia greca: argomento degno di un futuro articolo…
Altri articoli di Storia qui!
L’ha ripubblicato su The sense.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie moltissimo oer l’attenzione puntuale e benevola.
Un caro saluto
sv
"Mi piace"Piace a 1 persona
Di nulla! Giro all’autore dell’articolo :))
"Mi piace""Mi piace"