Storia politica e storia letteraria di Roma
Il contributo che presentiamo oggi – nono di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.
Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.
Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Petronio, arguzia ed estetica
- Velleio Patercolo, Pompeo Trogo, Curzio Rufo: Celebrazione e dissenso
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione

9. «Satura quidem tota nostra est…»
Questa famosa affermazione di Marco Fabio Quintiliano (Inst. Orat., X, 1) contiene la orgogliosa rivendicazione di un genere letterario unico, totalmente autoctono nella letteratura di Roma e che mai venne esplorato da autori greci.
Al contrario, un genere letterario che affonda le sue radici nella cultura ancestrale più profonda dell’Urbe (già dalla salacità mordace dei «fescennini», e poi dei «carmina triumphalia»), nel quale viceversa gli autori della letteratura latina arrivarono a eccelse vette artistiche, non meno che umane, proponendo diversi stili e registri a variegarne l’intento moraleggiante nell’arco delle diverse epoche: dalla Repubblica all’Impero.
Abbiamo pertanto il “pioneristico” Gaio Lucilio, capace di declamare fino a 2000 versi in un’ora mantenendosi in equilibrio su una gamba sola (secondo una famosa immagine proposta da Orazio – I, 4), fino alla serenità che permea le conversazioni dello stesso Orazio: in versi dove sembra avvertirsi l’eco di dialoghi e dissertazioni tra amici (versi che caratteristicamente sono per l’appunto espressi in forma di «sermones»). Lo sguardo di Orazio è permeato da un sorriso leggero e compartecipe, quello di chi è consapevole che le caratteristiche dell’essere umano (quelle buone così come le meno buone, cioè sia i pregi che i difetti) sono in primo luogo anche le sue: nei suoi versi risuona, una volta di più, l’eco del «homo sum, nihil humani a me alienum puto» di Publio Terenzio Afro (commedia Heautontimorùmenos, verso 77 – anno 165 a.C.), non meno che del «the web of our life is a mingled yarn, good and ill together: our virtues would be proud, if our faults whipped them not» di William Shakespeare (dalla commedia All’s well that ends well – Atto IV, scena III).
In Orazio c’è una vera arte nel disegnare una galleria di umanità: per esempio tutta la variegata psicologia e la descrizione quasi sociologica della tipologia dei bevitori, mentre d’altro canto sorge la conversazione, anche su registri elevati («Ergo sermo oritur» – II, 6, 67-74); nella stessa composizione, il finale con l’uso sapiente dell’apologo nel disegnare i due sorci (vv. 79-117, in un’immagine che ha avuto una straordinaria fortuna anche nei secoli successivi) porta un riflesso della sensibilità artistica di Fedro. Ancora, il celeberrimo attacco della Satira Nona del Libro I, con tutta la distanza tra la leggerezza di quell’andare a zonzo immerso in chissà quali fantasticherie e totalmente immerso in quelle bagatelle senza importanza («Ibam forte Via Sacra, sicut meus est mos, nescio quid meditans nugarum, totus in illis», vv 1-2) e la insistente petulanza dell’inopportuno “seccatore” che aveva incrociato in modo del tutto casuale.
La parabola letteraria della produzione satirica in Roma riflette – al pari della retorica – l’influsso dell’evoluzione del quadro politico e della trasformazione della struttura stessa della società dell’Urbe, dall’età repubblicana a quella imperiale.
Aulo Persio, la satira scolastica
In un’epoca in cui il primato della Scuola appare poter deprimere gli slanci dell’ingegno e della produzione artistica, spicca paradigmatica la figura di Aulo Persio (34-62 d.C.). Ben al di là della brevità della sua esistenza, fu autore dalla avara produzione letteraria (sei satire, di cui l’ultima rimasta incompiuta): il che rappresenta con ogni probabilità un riflesso del dover cercare faticosamente all’esterno – in modo a volte anche lambiccato – ciò che non si avverte o risuona al proprio interno; ancora, una difficoltà (anche tecnica) nello scrivere, uno stile indaginoso che appesantisce il testo e che ne ha reso proverbiale l’oscurità. In Persio, lo stoicismo appare come una “gabbia” vuota: una filosofia che – come ben noto – ha in altri casi dettato invece immortali riflessioni, permeando i testi di autori e pensatori greci e latini.
In questo caso, l’elaborazione appare priva di umanità: l’intento moralistico di Persio – che ne assicurò l’enorme fortuna nelle epoche successive – è quello di uno spirito arido. Quello di un uomo capace di predicare, ma declamando sermoni che restano lontano dalla sensibilità di chi legge.
Rimane memorabile il giudizio severo, un’autentica e inappellabile stroncatura, proposto da Concetto Marchesi nella sua Storia della Letteratura Latina:
“A Persio mancò la qualità che fa i veri poeti: la immaginazione. A questo naturale difetto si aggiunse l’azione mortificante di una educazione domestica e scolastica a cui il giovane si abbandonò con la umiltà devota di chi deve ogni cosa cercare fuori di sè. […] Volle essere serrato e vigoroso, e riuscì contorto e affannato; volle colorire e schiarire il pensiero e lo nascose dentro metafore strane e rattrappite; volle dare naturalezza e facilità al dialogo, e col dialogo soprattutto lo rese imbrigliato e oscuro. […] A lui manca la facoltà di abbandonarsi alla sensazione pura e semplice delle cose, di concedere sé stesso al mondo e di sentire una parte del mondo in sé stesso. Egli appartiene interamente alla scuola.”

Lo zenit della satira latina in Età Imperiale
La satira latina è un mondo, o forse meglio un universo: la angustia dell’orizzonte individuale e poetico di Aulo Persio stride – a maggior ragione – con quella sorta di «unicum» letterario già rivendicato da Quintiliano; tuttavia, a cavallo tra il I e II secolo d.C. la letteratura della latinità imperiale vedrà quelli che sono forse i massimi autori di questo genere letterario: Valerio Marziale e Decimo Junio Giovenale. Poeti diversi tra loro, ma accomunati da una profondità straordinaria: i loro messaggi e riflessioni ci parlano dell’essere umano e continuano ad impattare profondamente i lettori a distanza di secoli e millenni, in virtù di una diacronica attualità. Una critica, caustica o a tratti feroce, di vizi pubblici e privati: in qualunque caso, uno sguardo che – da un punto d’osservazione privilegiato – penetra nel profondo del tessuto sociale, politico ed economico della società romana del I secolo dell’Era Volgare.
Analogie e differenze. Se il primo elemento di distinzione sta nella loro provenienza (uno provinciale e l’altro di schietta origine italica), colpisce tuttavia la sostanziale analogia tra due passaggi che possono essere assunti quali “manifesti programmatici” della poetica dei due autori:
«Non hic Centauros, non Gorgonas Harpyiasque invenies: hominem pagina nostra sapit. Sed non vis, Mamurra, tuos cognoscere mores nec te scire: legas Aetia Callimachi» (Marziale, X, 4).
[Qui non troverai Centauri, né le Gorgoni e le Arpie: la nostra pagina conosce l’uomo. Ma se non vuoi conoscere né te stesso né i tuoi costumi, Mamurra, allora leggi gli Aitia di Callimaco]
«si natura negat, facit indignatio versum qualemcumque potest, quales ego vel Cluvienus. Ex quo Deucalion nimbis tollentibus aequornavigio montem ascendit sortesque poposcit paulatimque anima caluerunt mollia saxa et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas, quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.» (Giovenale, I, 79-86)
[se la natura non vuole, l’indignazione detta i versi, come può oppure come posso farlo io o un Cluvenio qualsiasi. Sin dal tempo in cui Deucalione, tra gli scrosci che gonfiavano il mare, con la nave raggiunse in cima il monte a chiedere il proprio destino e a poco a poco il soffio della vita sciolse al suo calore le pietre e ai maschi Pirra offrí vergini ignude, tutto ciò che gli uomini hanno bramato e temuto e odiato, quanto hanno gioito e intrigato, è la varia materia del mio canto]
A nessuno dei due fu concesso di dedicarsi all’officio letterario in condizioni di agiatezza: Marziale per tutta la vita dovette fare i conti con le ristrettezze e miserie della clientela, mentre Giovenale – pur in assenza di notizie dettagliate in merito alla sua esistenza – dopo aver cercato con ogni probabilità invano i favori o la protezione di qualche potente, pare abbia finito per scontare addirittura con un esilio (pur edulcorato sotto la veste di un comando militare in una provincia remota) l’aver criticato con i suoi versi un favorito dell’Imperatore (VII, 90-93). Pur ammettendo che esperienze dolorose abbiano caratterizzato la vita di Giovenale, che sia morto in esilio è notizia non confermata: tale situazione potrebbe invece rispondere a un ben noto “topos” (τόπος) o luogo comune biografico, con riferimento per esempio al caso di Publio Ovidio.
Ma le similitudini finiscono qui. Questi due grandissimi poeti svolsero ognuno un personale tipo di satira: da un lato nel solco della tradizione di questo genere letterario nella letteratura latina, d’altro canto vivendo la loro arte in modo squisitamente personale e in piena compenetrazione con lo scenario che fece da sfondo alla loro esistenza.

Valerio Marziale, l’apogeo dell’arte dell’epigramma
Valerio Marziale (40-104 d.C) riprende un genere che era già stato patrimonio dei «Poetae Novi», nell’Età di Cesare: proprio con questo poeta di origine iberica – nato a Augusta Bilbilis sulle rive del fiume Salone nella Hispania Tarraconensis (nei pressi della attuale città di Calatayud, in terra d’Aragona) – l’arte dell’epigramma raggiungerà il suo apogeo.
Versi di una incredibile e straodinaria immediatezza, capaci di sorprendere ogni volta il lettore: solo apparentemente frutto di improvvisazione linguistica e letteraria, sono al contrario il prodotto di un ricercatissimo «labor limae». Leggere le opere di Valerio Marziale, la cui ampia produzione si articola in 12 libri con oltre 1500 epigrammi a cui vanno aggiunte altre due raccolte che contengono componimenti scritti come per occasioni specifiche (ripettivamente per gli ospiti, o come doni da lasciare), è come entrare in una pinacoteca: o forse anche in una galleria di specchi.
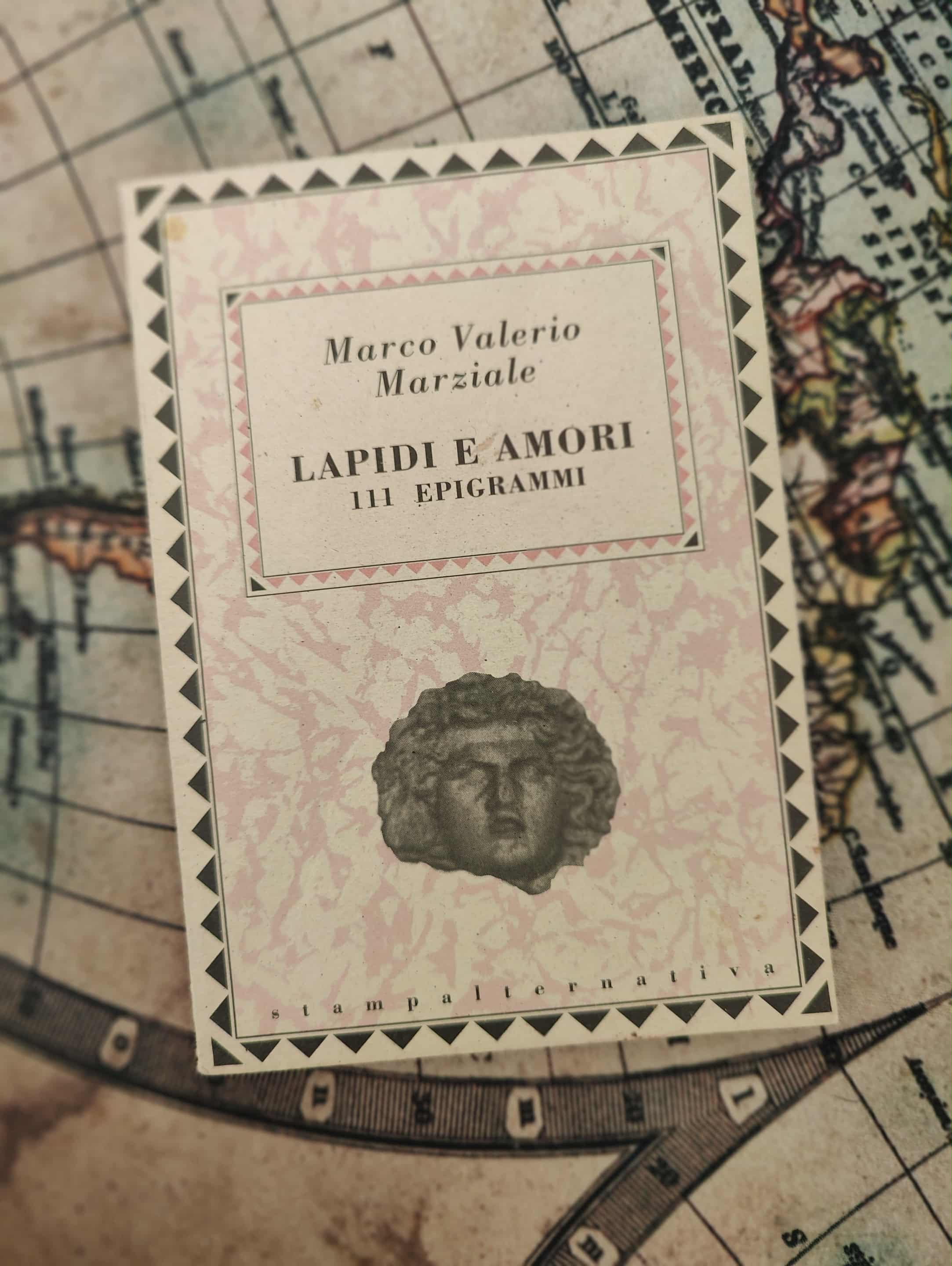


Una «brevitas» che colpisce moltissimo, suscitando spesso il riso ma nel contempo evocando riflessioni profonde: l’anima umana che si specchia nelle sue multiformi rappresentazioni, oppure che vede rappresentate situazioni di quotidianità dell’esistenza nelle quali si può risconoscere e trovare tracce di sé. La sua opera, come una pinacoteca quindi: una galleria di schizzi di immediata incisività, in cui talora il lettore/spettatore può riconoscere o percepire situazioni anche personalmente sperimentate. Solo qualche esempio, puntiforme:
«Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus: / quod vispillo facit, fecerat et medicus» (I, 47)
[Poco tempo fa Diaulo faceva il medico. Ora fa il becchino. / Beh, quello che fa ora da becchino lo aveva fatto anche quando era medico]
«Oculo Philaenis semper altero plorat. / Quo fiat istud quaeritis modo? Lusca est» (IV, 65)
[Piange sempre Fileni; e con un occhio solo. / “Ma come è possibile?” vi chiedete. È guercia]
«Cur non mitto meos tibi, Pontiliane, libellos? / Ne mihi tu mittas, Pontiliane, tuos» (VII, 3)
[Perché non ti mando, Pontiliano, i miei libri? / Perché tu non mi spedisca i tuoi].
Tra le diverse componenti della vita, non canterà però il sentimento amoroso (VIII, 73, 3-4): «Si dare vis nostrae vires animosque Thaliae Et victura petis carmina, da quod amem.», “Se vuoi dar cuore o forza a questa mia Musa giocosa, dammi un amore e avrai dei canti immortali”.
Conosce bene lo spettacolo degli amori cortigiani o mercenari tipici della società del suo tempo, ma è mancata nella sua vita una figura femminile che come una musa gli ispirasse un amore profondo e totalizzante: una Cynthia, una Lycoris, una Delia, o una Nemesis… Questa è una componente in comune con Quinto Orazio, alla cui vita e poesia è mancata una figura femminile del calibro di quelle che hanno permeato l’anima dei grandi elegiaci dell’età augustea. Ma in Orazio si intravede la presenza di figure di “amiche” del tutto peculiari: donne affascinanti con cui il poeta di Venosa instaura un rapporto molto profondo che si indovina fatto di incontri, conversazioni o silenzi, di meditazioni pensierose magari davanti a un calice di Falernum; la rappresentazione più compiuta di questa figura è ovviamente Leuconoe, quella “donna dalla mente candida” con la quale discute di aruspicina e brevità della vita («Tu ne quaesieris, scire nefas», Odi, I, 9, 1).
Allo stesso modo, Marziale vede con lucidità un altro elemento che caratterizza e al tempo stesso delimita la sua opera; legato alle ristrezze della clientela, una sostanziale povertà economica che avvelenerà tutta la sua vita, negandogli la serenità di un «otium» che gli consentisse di potersi dedicare alla composizione, quella condizione che fu invece concessa per esempio a Orazio o Virgilio (I, 107, 2-4): «Saepe mihi dicis, Luci carissime Iuli, scribe aliquid magnum: desidiosus homo es. Otia da nobis, sed qualia fecerat olim Maecenas Flacco Vergilioque suo». Quella di Marziale non è pigrizia, è una condizione – nonché ispirazione – di tipo diverso: evidentemente anche molto diversa anche rispetto alla «paupertas audax» sperimentata proprio da Orazio («paupertas impulit audax ut versus facerem.», Epist. II, 2, 51-52).
Il poeta, uomo di origine provinciale, sempre sarà legato all’Urbe da un sentimento contrastato: quasi in un ideale «odi et amo»; non può staccarsi da Roma, anche se con intervalli di soggiorni in terra iberica dettati dalla nostalgia per la terra natale. Quella Roma che lo estenua e lo sfinisce, che lo vessa anche fisicamente e non lo lascia dormire (X, 75): «Quid concupiscam quaeris ergo? Dormire». E allora è forse proprio Roma, e non Cynthia o Delia o Lycoris, la sua Musa ispiratrice: che gli ha dato gloria di poeta ben più che denaro (XI, 3), ma che rimane per lui fonte di un tormento che non può cessare.
Marziale era stato fin da subito oggetto di biasimo per la licenziosità di alcuni dei suoi componimenti (un atteggiamento censorio che è poi perdurato nei secoli): tuttavia, da un lato è impossibile non notare che l’immediatezza ed il realismo del linguaggio sono una componente essenziale del suo dipingere in chiave letteraria – senza reticenze – l’esistenza umana nelle sue multiformi manifestazioni («hominem pagina nostra sapit», X, 4, 10), sullo sfondo della società in cui vive; d’altro canto, sembra opportuno ricordare che il poeta stesso si era difeso dall’accusa di scurrilità contrapponendo all’audacia di certi suoi versi la cristallina onestà della sua vita (I 4, 8): «lasciva est nobis pagina, vita proba», “la mia pagina è lasciva, la vita onesta”.
In qualunque caso, della grandezza poetica di Valerio Marziale ci fu immediata percezione anche presso i suoi contemporanei; così di lui ebbe a scrivere Plinio il Giovane, alla notizia della sua scomparsa (Epist. III, 21):
«Erat homo ingeniosus acutus acer, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis nec candoris minus. (…) At non erunt aeterna, quae scripsit; non erunt fortasse, ille tamen scripsit, tamquam essent futura.»
[Era un uomo ingegnoso, acuto e pungente che aveva nello scrivere moltissimo di sale e di fiele e non meno di sincerità. (…) Ma non saranno eterne le cose che scrisse: non lo saranno forse; egli tuttavia le scrisse come se dovessero rimanere per sempre.]
“E per sempre rimasero.” (Concetto Marchesi)

Decimo Giunio Giovenale: «difficile est satira non scribere»
In quella Satira I che come già accennato contiene il manifesto programmatico dell’arte e dell’etica di Giovenale, si può percepire tutta l’intima sofferenza – a tratti espressa anche con livore rancoroso – che ne permea l’opera. Un grandissimo poeta, cui il genere stesso della satira calza come un vestito su misura; Giovenale è un tutt’uno con la sua opera: si potrebbe addirittura giungere ad affermare che se la satira non fosse già esistita in precedenza come genere letterario, il suo incoercibile slancio a poetare lo avrebbe portato a inventarla.
Il messaggio politico, poetico e morale di questo Aquinate che si colloca tra il I e il II secolo dell’Era Volgare (nato tra il 50 e il 60, deceduto a Roma dopo l’anno 127 d.C.) è già stato ampiamente discusso e ha reiteramente punteggiato le considerazioni formulate in questo elaborato: quasi come in un ideale contrappunto poetico ai concetti espressi nella tagliente prosa tacitiana.
In estrema sintesi, possiamo individuarlo come “il” poeta satirico per eccellenza: che conosce un suo personale tipo di satira; quella dell’invettiva e del sarcasmo, in cui spicca la capacità di concentrare – a tratti in modo tetro e inesorabile – il suo cupo risentimento: per esempio nei confronti della depravazione sessuale (Satira VI e Satira IX). D’altro canto è paradigmatica la sua avversione per il mondo greco, interpretato come un coacervo degli elementi che hanno corrotto il «mos maiorum» e la «pristina virtus». Un sentire che analogamente si concentra nella Satira III, permenadola nella sua interezza, oppure che gli detta versi colmi di inesorabile rancore nella Satira XIV (vv. 235-243): ma che trova la sua più compiuta rappresentazione in quel celeberrimo «Graecia mendax» della Satira X (vv. 174-175): «creditur olim velificatus Athos et quidquid Graecia mendax audet in historia», “noi crediamo che l’Athos fu una volta percorse da vele, noi crediamo a tutto quanto la Grecia bugiarda osa raccontare nelle sue storie”.


La sua temperie spirituale appare risentire di un paradosso, non a caso legato all’ambito sociale e politico che fa da sfondo alla sua esistenza. Una solo apparente contraddizione nei termini, già perfettamente inquadrata da Concetto Marchesi: che in un saggio monografico del 1921 scriveva “Giovenale è il poeta rivoluzionario della reazione conservatrice”. In una dicotomia lacerante, nel suo animo vivono lo spirito e gli ideali della antica Roma Quiritaria, nelle sue diverse componenti, mentre si trova a vivere nella Roma Imperiale al suo apogeo e nella sua dimensione cosmopolita: in quella Roma dove vede con esasperante e spietata lucidità gli elementi che ne hanno progressivamente corrotto l’essenza e che ne decreteranno la rovina.
È il poeta di una Roma antica, fatta di antica nobiltà e antica plebe: entrambe corrotte dall’inarrestabile azione di una ricchezza che ha trasformato la società a partire dai suoi strati e tessuti più profondi. Come annota ancora il Marchesi, in questo Giovenale non ha odi partigiani: arrivando a vedere con amara insofferenza l’effetto di un potere imperiale “che del popolo dei quiriti ha fatto un volgo di sudditi senza decoro né coscienza di vita civile, turba ignobile di servi e di lapidatori al seguito della fortuna, che tripudia sulla rovina di Seiano con la stessa foga onde lo avrebbe in quel medesimo istante salutato imperatore”. In questo passaggio della Satira X (vv. 72-81) quella «turba Remi» è oggetto di un’analisi molto profonda in termini di psicologia della folla; versi che non possono non rimandare ad analoghe amare considerazioni di Cornelio Tacito: «Vulgus mutabile subitis et tam pronum in misericordiam, quam immodicum saevitia fuerat», “Mutevole il volgo all’evento inatteso, tanto diventa incline a compassione quanto era stato smodato nella collera” (Hist., I, 69); «Vulgus […] cui una ex re publica annonae cura», “al volgo una sola cosa interessa dello Stato, l’annona” (Hist., IV, 38).
L’arte poetica di Giovenale è fatta di quadri, di immagini che propone e che sembrano scaturire dal profondo del suo animo: un qualcosa che lui stesso non riesce a descrivere o mostrare, ma soltanto avverte («hunc, qualem nequeo monstrare et sentio tantum» – VII, 56). Un’arte che lo ha preservato dal proporre delle aride prediche morali, malgrado sia un impietoso fustigatore della depravazione dei costumi, a tutti i livelli. In più, un’arte che lui sente come una forgia creativa dove l’animo è come se fosse un’incudine: ma che gli consente per esempio di evocare delle emozioni che il lettore riconosce come sue, immedesimandosi per esempio nelle paure di un viandante che porta un tesoro, alla vista di una canna agitata dal vento alla luce della luna («et motae ad lunam trepidabis arundinis umbras» – X, 21).
Aveva studiato eleoquenza e retorica, nella prima parte della sua vita (I, 1-14): la sua è una produzione poetica successiva, dell’età matura, dettatagli dalla vita e dalle sue esperienze. Ma proprio da quella cultura trae la capacità di utilizzare verbi e sostantivi come da prelevandoli da una tavolozza; in una rappresentazione della realtà che è fatta di immediatezza e di essenzialità: dai tratti dell’umanità primitiva, sullo sfondo di una ingens silva che rimanda a una temperie di sapore vichiano (VI, 5-10), alla descrizione di Messalina (VI, 115-132) dapprima dipinta con una furtiva parrucca all’uscita dal palazzo imperiale e poi con una maglia d’oro nel lupanare. Le immagini, estranee a qualsiasi gusto per la metafora o per l’allegoria, sono la compiuta espressione della «farrago» vissuta con profonda sofferenza: arte vera, che si innesta su un genere letterario di secolare tradizione, ma di grandissima originalità creativa e profondità spirituale.
Prosegue con “Lucano, crasi tra epica e storia”
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta.
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”.
- Tacito, analisi politica e passione tragica.
- Lucrezio, ragione e angoscia.
- Cicerone, tra otium e negotium.
- La crisi dell’arte retorica.
- Velleio Patercolo, Pompeo Trogo, Curzio Rufo: Celebrazione e dissenso.
- Petronio, arguzia ed estetica.
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica.
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
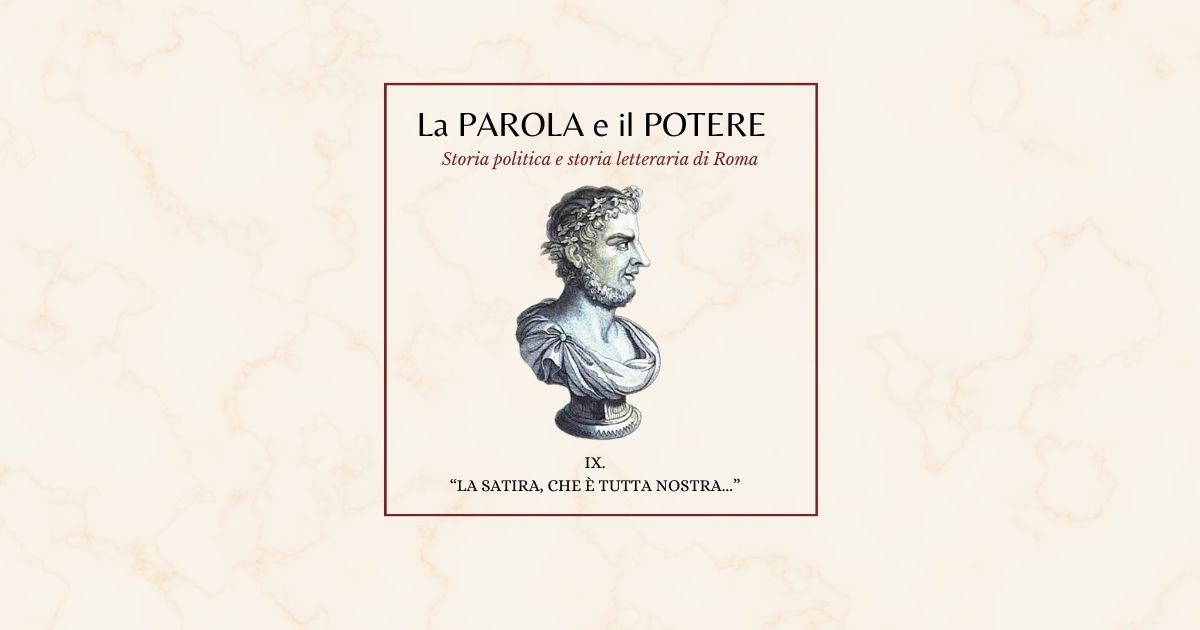
Lascia un commento