Storia politica e storia letteraria di Roma
Il contributo che presentiamo oggi – ottavo di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.
Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.
Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Petronio, arguzia ed estetica
- Alcuni storici minori
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
8. Velleio Patercolo, uno storico tra narrazione e interpretazione
Un contributo prezioso, anche parzialmente inatteso, al dibattito sulla crisi della retorica – ma anche più in generale della produzione letteraria – proviene dalle pagine di Velleio Patercolo, pregevole storico dell’età di Tiberio. Questo Autore, dando prova di una profonda conoscenza anche della letteratura greca, si interroga sugli elementi che possano condizionare il fiorire di attività letterarie in alcune epoche al contrario di altre (I, 16-17): l’esempio della tragedia (Eschilo-Sofocle-Euripide), ma anche delle due fasi della commedia (Aristofane-Cratino-Eupoli, Menandro-Difilo-Filemone), generi letterari che hanno espresso i loro “assi” in una generazione sola.
Velleio non osa spiegare il fenomeno di una simile concentrazione di vette artistiche assolute in epoche ristrette: ma prova a proporre una motivazione che gli pare verosimile (I, 17, 5-7), secondo la quale l’opera di un sommo artista stimola l’attenzione e l’emulazione di chi gli sta intorno (o per invidia, o per ammirazione…), esaltandone le qualità d’ingegno:
[Per quanto spesso indaghi i motivi per i quali ingegni simili, in quanto a grandezza, interessi e realizzazioni, chissà perché si ritrovano ad essere contemporanei tra loro, tuttavia non riesco a dedurne alcuno che consideri vero, bensì alcuni comunque verosimili, e questi, soprattutto, tra gli altri: ovvero, che il desiderio di emulare alimenta gli ingegni e che ora l’invidia, ora l’ammirazione rinfocola il desiderio di imitare e che, per natura, ciò che si è cercato di ottenere con la passione più grande, giunge ad altezze elevatissime; tuttavia, è difficile persistere nella perfezione e sempre secondo natura regredisce ciò che non può migliorarsi. E come al principio c’infervoriamo a dover raggiungere coloro i quali giudichiamo i migliori, così non appena disperiamo di poterli superare o quantomeno eguagliare, la passione, insieme con la speranza, sfuma, e smette di perseguire ciò non può conseguire; e, abbandonando una materia per così dire appannaggio di altri, va in cerca di una nuova, e – abbandonato quel campo in cui non siamo in grado di emergere – andiamo in cerca di un altro, nel quale sforzarci; ne segue che un cambiamento frequente e costante è il più grande impedimento della perfezione.]
Testo in latino
«Huius ergo recedentis in suum quodque saeculum ingeniorum similitudinis congregantisque se et in studium par et in emolumentum causas cum saepe requiro, numquam reperio, quas esse veras confidam, sed fortasse veri similes, inter quas has maxime. Alit aemulatio ingenia, et nunc invidia, nunc adrmiratio imitationem accendit, naturaque quod summo studio petitum est, ascendit in summum difficilisque in perfecto mora est, naturaliterque quod procedere non potest, recedit. Et ut primo ad consequendos quos priores ducimus accendimur, ita ubi aut praeteriri aut aequari eos posse desperavimus, studium cum spe senescit, et quod adsequi non potest, sequi desinit et velut occupatam relinquens materiam quaerit novam, praeteritoque eo, in quo eminere non possumus, aliquid, in quo nitamur, conquirimus, sequiturque ut frequens ac mobilis transitus maximum perfecti operis impedimentum sit.»
Una generazione sola, dunque, tutto in tempi molto ristretti: a tale proposito, Velleio riporta esempi della letteratura sia greca che latina, e di diversi generi; tutto questo perché, secondo una parafrasi proposta da Concetto Marchesi nella sua Storia della Letteratura Latina, “[…] ogni cosa ardentemente perseguita giunge naturalmente alla sommità. Ciò che è perfetto non può durare a lungo nel suo stato di perfezione: e quello che non può progredire, decade”.
Il sommo latinista italiano prosegue affermando che la tesi espressa da Velleio Patercolo, anche se ha una parte di verità, risente tuttavia di un approccio scolastico; infatti: “[…] l’emulazione, l’ammirazione, l’invidia sono stimoli all’opera: non sono elementi creativi del genio individuale che, nel campo dell’arte soprattutto, è opera del caso; giacché l’arte – quando non sia quella della guerra – non ha bisogno delle occasioni per esprimersi, se è prepotente la natura dell’individuo. […] per esempio, non è colpa né merito dei tempi se nella tragedia, considerata nelle immortali e universali produzioni del genio artistico, si va da Euripide a Guglielmo Shakespeare”.
Le riflessioni di Velleio Patercolo in termini di produzione letteraria, molto profonde, rendono conto della grandezza di uno storico che appare essere stato troppo a lungo sottovalutato o comunque frettolosamente etichettato come “storiografo di corte”: scontando forse una semplicistica contrapposizione con un Cremuzio Cordo, considerato quale alfiere di una sorta di “storiografia d’opposizione”. Come ben noto, Cremuzio Cordo era stato accusato di quello che con terminologia moderna si definisce “reato d’opinione”: «Cremutius Cordus postulatur novo ac tunc primum audito crimine, quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset » [Tacito, Annales, IV, 34]); proprio la prosa tacitiana aveva assicurato fama imperitura a una figura di intellettuale le cui vicende possono essere assunte a paradigma dell’impossibilità di vietare la circolazione delle idee, sotto qualsiasi latitudine (Annales, IV, 35].
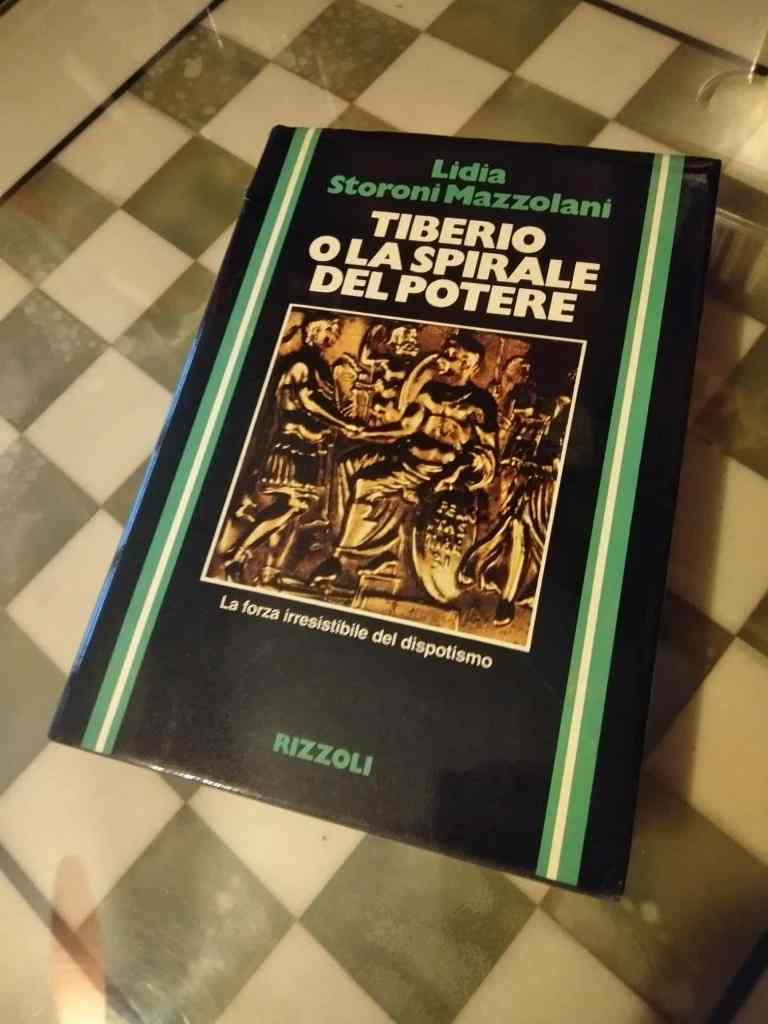
Una storiografia nuova nell’età di Tiberio
In realtà anche l’opera di Velleio Patercolo rappresenta un elemento di rilievo nell’evoluzione del genere storiografico: a cominciare dal piglio sintetico e non più annalistico (la sua narrazione si articola nell’arco di due volumi), ma anche dai contenuti. Non più una visione annalistica, ma un compendio che si trasforma in una sorta di saggio sulla Storia di Roma: in un’opera nella quale trovano spazio non solo gli avvenimenti storici e politici, ma come si è visto anche quelli afferenti alla sfera culturale e letteraria, e in una prospettiva che considera – oltre a Roma – anche popoli e civiltà con cui l’Urbe è progressivamente entrata a contatto.
Si può inoltre ipotizzare che la novità di questo approccio nella tecnica storiografica risenta di un altro elemento: la consapevolezza che con il consolidarsi del Principato il passaggio da Repubblica a Impero rappresenti un ante e un post, con un’epoca imperiale che si sta muovendo nella sua fase iniziale.
A Velleio Patercolo è stato a più riprese imputato – in modo forse anche troppo semplicistico – un intento puramente panegiristico nei confronti di Tiberio, imperatore a lui contemporaneo; la realtà appare però più complessa e meritevole di una valutazione maggiormente articolata. Il ruolo di Velleio Patercolo come cronista, essendo stato testimone oculare diretto dei fatti, presenta delle interessanti analogie con quanto accadrà oltre tre secoli dopo con Ammiano Marcellino nel narrare le vicende che videro protagonista Flavio Claudio Giuliano.
Proprio la sua presenza dal vivo, sul campo, gli consente infatti non solo di raccontare, ma di entrare nelle pieghe delle situazioni e della psicologia, individuale e collettiva (II, 104):
[Fu allora che, dopo aver esercitato le funzioni di tribuno del campo, mi rese soldato di Tiberio Cesare. Per cui, mandato subito dopo l’adozione in Germania insieme a lui in qualità di prefetto della cavalleria, successore della carica di mio padre io fui per nove anni consecutivi, sia in qualità di prefetto sia in quella di ambasciatore, testimone e, per quanto mi permettesse la mia mediocrità, compartecipe delle sue azioni straordinarie. Né mi sembra che la condizione dei mortali ammetta un esempio simile a quello spettacolo, di cui io godetti, quando attraverso lapiù popolata zona d’Italia e ogni contrada delle provincie Galliche, rivedendo il Vecchio comandante, Cesare prima che per il nome per i meriti e le virtù, ciascuno si felicitava più abbondantemente con sé stesso che con lui. Ma invero le lacrime, provocate dalla gioia al suocospetto, e l’ardore, e l’in un certo senso straordinario entusiasmo del saluto e la smania ditoccargli una mano dei soldati, che non si trattenevano dal soggiungere ininterrottamente:”Vediamo proprio te, o generale? Ti riceviamo dunque in salute?”, e poi: “Io fui con te in Armenia, generale! Io in Rezia! Io ho ricevuto da te delle ricompense in Vindelicia! Io in Pannonia! Io in Germania!” non possono essere espressi a parole e forse solo a fatica possono essere creduti.]
Testo in latino
«Hoc tempus me, functum ante tribunatu, castrorum Tiberii Caesaris militem fecit: quippe protinus ab adoptione missus cum eo praefectus equitum in Germaniam, successor offici patris mei, caelestissimo rumeius operum per annos continuos novem praefectus aut legatus spectator, tum pro captu mediocritatis meae adiutor fui. Neque illi spectaculo, quo fructus sum, simile condicio mortales recipere videtur mihi, cum per celeberrimam Italiae partem tractumque omnem Galliae provinciarum veterem imperatorem et ante meritis ac virtutibus quam nomine Caesarem revisentes sibi quisque quam illi gratularentur plenius. At vero militum conspectu eius elicitae gaudio lacrimae alacritasque et salutationis nova quaedam exultatio et contingendi manum cupiditas non continentium protinus quin adiicerent, “videmus te, imperator? Salvum recepimus?” Ac deinde “ego tecum, imperator, in Armenia, ego in Raetia fui, ego a te in Vindelicis, ego in Pannonia, ego in Germania donatus sum” neque verbis exprimi et fortasse vixmereri fidem potest.»
Così si esprime lo storico nei confronti del comandante militare, ancora prima che dell’Imperatore e statista (II, 114):
Testo in latino
«Per omne belli Germanici Pannonicique tempus nemo e nobis gradumve nostrum aut praecedentibus aut sequentibus imbecillus fuit, cuius salus ac valetudo non ita sustentaretur Caesaris cura, tamquam distractissimus ille tantorum onerum mole huic uni negotio vacaret animus. Erat desiderantibus paratum iunctum vehiculum, lectica eius publicata, cuius usum cum alii tum ego sensi; iam medici, iam apparatus cibi, iam in hoc solum uni portatum instrumentum balinei nullius non succurrit valetudini; domus tantum ac domestici deerant, ceterum nihil, quod ab illis aut praestari aut desiderari posset. Adiciam illud, quod, quisquis illis temporibus interfuit, ut alia, quae retuli, agnoscet protinus: solus semper equo vectus est, solus cum iis, quos invitaverat, maiore parte aestivarum expeditionum cenavit sedens; non sequentibus disciplinam, quatenus exemplonon nocebatur, ignovit; admonitio frequens, interdum et castigatio, vindicta tamen rarissima.»
[Per l’intera durata della guerra di Pannonia e di Germania, nessuno di noi – inferiore o superiore a me per grado – si ammalò senza che le sue condizioni di salute non fossero sostenute dalla premura di Cesare, quasi che il suo animo – per quanto occupatissimo in faccende di estrema importanza – avesse a cuore esclusivamente quest’unico compito. Per chi ne avesse bisogno, era stata messa a disposizione una carrozza munita di cavalli pronti a partire; la sua lettiga personale era stata messa a disposizione di tutti, e io stesso, come gli altri, ne sperimentai l’utilità; e inoltre furono fatti venire medici (ausiliari), venne fatta pervenire l’attrezzatura per il cibo e per il bagno, per l’unico scopo di soccorrere i malati; mancavano soltanto la casa e i fattori; per il resto, non mancava alcunché di quanto da questi potesse essere fatto o ad essi richiesto. Aggiungerò quest’altro fatto, che chiunque fosse presente in quella situazione, di certo confermerà, come le altre cose che ho riferito: (Tiberio) – unico e solo – era sempre a cavallo, unico e solo consumò i pasti sedendo insieme a coloro che aveva invitato, per la maggior parte della campagna estiva. Concesse il perdono a coloro che non seguivano la disciplina, entro questo limite: che non si nuocesse con il cattivo esempio. L’ammonizione era frequente, talora vero e proprio rimbrotto; ciononostante, le punizioni fioccavano molto di rado.]
Alla fine del capitolo successivo, dopo aver concluso la narrazione delle ostilità in Dalmazia, Velleio evidenzia un altro lato della psicologia dell’Imperatore (II, 115.5): un tratto che risulta coerente la personalità di Tiberio e la sua gestione dello stato:
«Nihil in hoc tanto bello, nihil in Germania aut videremaius aut mirari magis potui, quam quod imperatori numquam adeo ulla opportuna visa. estvictoriae occasio, quam damno amissi pensaret militis semperque visum est gloriosissimum, quod esset tutissimum, et ante conscientiae quam famae consultum nec umquam consilia ducisiudicio exercitus, sed exercitus providentia ducis rectus est.»
[Nulla nel corso di una così grande guerra potei io vedere in Germania di più stupendo e degno di ammirazione, quanto che mai agli occhi del nostro generale l’opportunità di una vittoria sembrò così a portata di mano da volerla pagare con il sacrificio dei soldati. Sempre gli parve motivo di gloria solo la decisione più cauta e sicura e, meno preoccupato della fama che di dare ascolto alla propria coscienza, non lasciò mai che l’opinione dell’esercito governasse la prudenza del capitano, ma bensì la prudenza del capitano l’esercito.]
Anche nella prosa di Velleio, Tiberio si conferma figura di enorme complessità e dalla personalità che – a distanza di millenni – continua ad esercitare un grande fascino; “Tiberio, uno dei più grandi e infamati imperatori della storia di Roma”: questa, l’interpretazione proposta da Concetto Marchesi in un celebre discorso pubblico. Parole che confermano una grande complessità interpretativa: una complessità che nasce in primo luogo dal fatto che Tiberio non aveva mai coltivato ambizioni di ascendere alla dignità imperiale, prima di essere indicato da Ottaviano Augusto come suo successore. Precedentemente, si era invece messo in luce come uno dei più capaci condottieri militari di Roma e dando inoltre prova di sicuro acume politico: nell’arco di varie campagne – tra Pannonia, Illiria, Rezia e Germania – pose le basi di quella che in epoche successive sarebbe diventata la frontiera settentrionale dell’Impero; il cosiddetto ‹‹Limes››, renano e danubiano. All’atto pratico, invece di imbarcarsi in costose campagne in territorio straniero, Tiberio intuì come la priorità fosse rappresentata dal consolidamento dei ‹‹claustra imperii››: con la costruzione di strutture difensive, non meno che con le armi della diplomazia e tramite una politica aliena da ingerenze negli interessi di altri popoli e stati.

Malgrado la sfavorevole tradizione che ha accompagnato la sua figura attraverso i secoli, Tiberio potrebbe essere ricordato come un esempio di come regnare: infatti, è sempre più facile essere il “Padre della Patria”, piuttosto che la persona che deve gestire la sua eredità, curando la “creatura” del fondatore dello stato nella sua fase di successiva crescita e sviluppo. Concretamente, sembra possibile affermare che il più grande successo di Tiberio, postumo, sia stato rappresentato dal lasciare in eredità all’atto della sua scomparsa un impero in condizioni talmente eccellenti (economicamente, socialmente e militarmente parlando) al punto da potercisi permettere di attaccare il suo ricordo senza che la solidità dello stato ne risultasse danneggiata. In qualunque caso, sembra opportuno sottolineare che mai la sua figura fu oggetto di «damnatio memoriae» dopo la morte: cosa che invece seppero guadagnarsi Caligola, Nerone e Domiziano.
Al di là della schiettezza dell’affetto e stima del Velleio “soldato” per il suo antico comandante, nelle pagine dello storico sembra quindi balenare la presenza dell’embrione di una percezione più profonda della statura all’Imperatore. Una valutazione della figura di Tiberio non può chiaramente prescindere da quanto riportato nelle pagine di Cornelio Tacito; che è stato il suo grande accusatore, certo, ma a cui dobbiamo essere grati. Nei primi sei libri degli Annales «ab excessu Divi Augusti» (che già in quanto tali costituiscono un vero monumento letterario) il massimo storico della latinità ci restituisce intatto l’arcano di una personalità schiva e complessa, amareggiata dalla vita (in un quadro coerente anche con alcune delle suggestioni proposte da Velleio). L’uomo, prima del Cesare: un uomo che mai poté dimenticare una sposa amatissima, da cui fu costretto a divorziare per ragioni politiche; un uomo che provava ribrezzo per il servilismo e che invano cercò amicizia: trovando invece solo adulazione e conoscendo la solitudine del potere. Un uomo che durante le notti insonni nell’isola di Capri scrutava il cielo stellato, cercando di penetrare nei misteri del futuro e del destino: in bilico tra ‹‹fortuna›› e ‹‹fatum››, caso e predestinazione; un tormento incoercibile che Tacito ha dato mostra di condividere, in nome della comune condizione umana (Ann., VI, 22).
Pompeo Trogo e Curzio Rufo: la reazione della “storiografia antiromana”
Due storici dell’epoca della dinastia giulio-claudia, che suggeriscono delle interpretazioni comuni: a cominciare dall’argomento della loro narrazione storiografica, che risulta fondamentalmente incentrata sul personaggio di Alessandro Magno. Una scelta in controcorrente, quindi, non solo rispetto a un Tito Livio ma anche – in epoca successiva – a un Ammiano Marcellino; perché uno storico latino dovrebbe scegliere di narrare le gesta del sovrano macedone?
Tale scelta appare ascrivibile a una temperie di reazione anti-virgiliana, o anti-liviana, nel senso di contraria a quella canonizzazione dell’aspirazione egemonica che aveva visto la sua realizzazione nella fondazione dell’Impero: una predestinazione al dominio che come già accennato il poeta mantovano aveva attribuito a un disegno superiore («His ego nec metas rerum nec tempora pono: Imperium sine fine dedi», nelle parole di Giove – Libro I, 278-279), per poi esprimerla più compiutamente nella profezia di Anchise al figlio, nel libro VI (vv. 847-853). Un passo che rappresenta una sorta di manifesto programmatico, la giustificazione e il fondamento morale e culturale dell’egemonia romana:
«Excudent alii spirantia mollius aera (credo equidem), vivos ducent de marmore vultus, orabunt causas melius, caelique meatus describent radio et surgentia sidera dicent: tu regere imperio populos, Romane, memento (hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos».
[Foggeranno altri con maggiore eleganza spirante bronzo, credo di certo, e trarranno dal marmo vivi volti, patrocineranno meglio le cause, e seguiranno con il compasso i percorsi del cielo e prediranno il corso degli astri: tu ricorda, o romano, di dominare le genti; queste saranno le tue arti, stabilire norme alla pace, risparmiare i sottomessi e debellare i superbi].
Le Historiae Philippicae di Pompeo Trogo, che si articolavano in quarantaquattro libri e risultano perdute nella stesura originale, ci sono pervenute nella epitome compilata da Giustino; proprio nella preparazione del compendio, il compilatore decise di omettere le parti che apparivano meno interessanti o comunque non strettamente funzionali alla narrazione degli avvenimenti: risultano quindi perdute una serie di notizie geografiche ed etnografiche dei popoli nominati nell’opera, elementi che sarebbero stati di sicuro interesse per i posteri. La voce di Trogo, originario della Gallia Narbonese e che scrive ai tempi di Augusto, da un lato sembra esprimere il dissenso proviciale verso il principio dell’Urbe dominatrice; d’altro canto, in una prospettiva più ampia, suggerisce una percezione più universale nella quale gli stati e gli imperi nascono, crescono e poi arrivano a dissoluzione: ancora in una sorta di teoria ciclica (ovvero biologica) della storia.
Pompeo Trogo aveva scritto una sorta di Storia Universale incentrata sull’Impero Macedone (la cui parabola andava a interrompersi – o forse meglio a saldarsi – con la più giovane potenza romana) e il cui personaggio centrale e massimo eroe era Alessandro Magno. Ancora più esplicito il disegno di Curzio Rufo, la cui opera appare databile ai tempi di Claudio, autore delle Historiae Alexandri Magni Macedonis in dieci libri: un’opera quindi del tutto focalizzata proprio sul sovrano macedone, di cui narra la vita e le imprese fino alla morte (323 a.C.), per poi trattare delle guerre tra i Diadochi.

Per ció che attiene all’impatto della figura e imprese di Alessandro sul mondo della cultura e della storia di Roma, un elemento di grande interesse è rappresentato dalle riflessioni proposte da Tito Livio. Nel libro IX del Ab Urbe condita (capp. 17-19) lo storico patavino entra nel merito specifico, in un lungo inciso – alla cui lettura in versione integrale si rimanda per completezza – dove disegna un ideale confronto politico e militare tra la res publica e il sovrano macedone e di cui si riportano di seguito alcuni passaggi.
[Per prima cosa, per cominciare dal confronto tra i condottieri, da parte mia non nego che Alessandro sia stato un generale straordinario: ma lo rese tuttavia più famoso il fatto che fu unico, che morì da giovane nel crescere della sua potenza, senza aver sperimentato ancora l’avversa fortuna. Per non parlare di altri famosi re e condottieri, grandi esempi di cadute umane, Ciro, che i Greci celebrano massimamente con lodi, che cosa se non una lunga vita, come ora Pompeo Magno, porse al mutar della fortuna? Dovrei passare in rassegna i generali romani, non tutti di tutte le età, ma proprio quelli con i quali consoli e dittatori avrebbe dovuto combattere Alessandro, (e cioè) Marco Valerio Corvo, Caio Marcio Rutulo, Caio Sulpicio, Tito Manlio Torquato, Quinto Publio Filone, Lucio Papirio Cursore, Quinto Fabio Massimo, i due Deci, Lucio Volumnio, Manlio Curio? Successivamente seguono grandi uomini (con cui Alessandro avrebbe dovuto combattere), se egli avesse combattuto contro Cartagine prima che contro Roma e se fosse passato in Italia più vecchio. In ciascuno di questi c’era tanto la stessa disposizione d’animo e d’ingegno che era in Alessandro, quanto la disciplina militare, tramandata di padre in figlio sin dalle origini della città, era passata in forma di scienza con norme universali.]
Testo in latino
«Iam primum, ut ordiar ab ducibus comparandis, haud equidem abnuo egregium ducem fuisse Alexandrum; sed clariorem tameneum facit quod unus fuit, quod adulescens in incremento rerum, nondum alteram fortunam expertus, decessit. Ut alios reges claros ducesque omittam, magna exempla casuum humanorum, Cyrum, quem maxime Graeci laudibus celebrant, quid nisi longa vita, sicut Magnum modo Pompeium, vertenti praebuit fortunae? recenseam duces Romanos, nec omne somnium aetatium sed ipsos eos cum quibus consulibus aut dictatoribus Alexandro fuit bellandum, M. Valerium Corvum, C. Marcium Rutulum, C. Sulpicium, T. Manlium Torquatum, Q. Publilium Philonem, L. Papirium Cursorem, Q. Fabium Maximum, duos Decios, L. Volumnium, M. Curium? deinceps ingentes sequuntur viri, si Punicum Romano praevertisset bellum seniorque in Italiam traiecisset. Horum in quolibet cum indoles eadem quae in Alexandro erata nimi ingeniique, tum disciplina militaris, iam inde ab initiis urbis tradita per manus, in artis perpetuis praeceptis ordinatae modum venerat.» (cap. 17).
«Quanta libet magnitudo hominis concipiatur animo; unius tamen ea magnitudo hominis erit collecta paulo plus decem annorum felicitate; quam qui eo extollunt quod populus Romanus etsi nullo bello multis tamen proeliis victus sit, Alexandro nullius pugnae non secunda fortuna fuerit, non intellegunt se hominis res gestas, et eius iuvenis, cum populi iam octingentesimum bellantis annum rebus conferre.» (cap. 18)
[Per quanta grandezza dell’uomo si immagini, tuttavia la sua sarà la grandezza di un solo uomo, raccolta in poco più di dieci anni di fortuna; e coloro che la esaltano a tal punto poiché il popolo romano, anche se in nessuna guerra, tuttavia è stato vinto in molte battaglie, mentre Alessandro ebbe prospera fortuna in tutte le battaglie, non capiscono che paragonano le imprese di un solo uomo, e anche giovane, con le imprese di un popolo che guerreggia ormai da ottocento anni.]
[Se Alessandro fosse stato sconfitto in un’unica battaglia, avrebbe perso la guerra: quale armata avrebbe potuto piegare i Romani, che non erano stati annientati dagli eventi di Caudio o di Canne? Se avesse riportato delle vittorie anche solo all’inizio, avrebbe rimpianto le spedizioni contro i Persiani, gli Indiani e l’imbelle Asia, e avrebbe affermato di aver combattuto fino a quel momento contro delle femminucce (come pare abbia detto Alessandro re dell’Epiro, ferito a morte, paragonando i successi nelle guerre combattute dal giovane re con le sue). A dir la verità, quando penso che nel corso della prima guerra punica i Romani combatterono ventiquattro anni di battaglie navali contro i Cartaginesi, mi sembra che la vita di Alessandro sarebbe bastata a stento per portare a termine quella sola guerra. E siccome Cartagine era unita a Roma da un antico trattato di alleanza, è probabile che il timore avrebbe portato a prendere insieme le armi contro il comune nemico le due città più potenti per armamenti e per uomini, e Alessandro sarebbe stato schiacciato dalle forze congiunte dei Cartaginesi e dei Romani. Anche se i Macedoni non erano più sotto la guida di Alessandro e se la loro forza non era più integra, i Romani ebbero ciò non ostante l’opportunità di sperimentare le armi macedoni nei conflitti contro Antioco, Filippo e Perseo, non solo senza mai subire sconfitte, ma senza mai correre alcun pericolo. Possano le mie parole non essere fraintese e tacciano le guerre civili: noi Romani non siamo mai stati messi in difficoltà da nemici a cavallo o a piedi, in campo aperto, a parità di posizioni, e tanto meno in zone a noi favorevoli. La nostra fanteria pesante può temere la cavalleria, le frecce, gli avvallamenti del terreno, i punti dove i rifornimenti risultino difficili, ma è perfettamente in grado di respingere – e sempre lo sarà – migliaia di eserciti più imponenti di quello dei Macedoni e di Alessandro, a patto però che duri per sempre l’amore per questa pace nella quale adesso viviamo e la preoccupazione per l’armonia nei rapporti tra i cittadini.]
Testo in latino
«uno proelio victus Alexander bello victus esset: Romanum, quem Caudium, quem Cannae non fregerunt, quae fregisset acies? ne ille saepe, etiamsi prima prospere evenissent, Persas et Indos et imbellem Asiam quaesisset et cum feminis sibi bellum fuisse dixisset, quod Epiri regem Alexandrum mortifero volnere ictum dixisse ferunt, sortem bellorum in Asia gestorum ab hoc ipso iuvene cum sua conferentem. Equidem cum per annos quattuor et viginti primo Punico bello classibus certatum cum Poenis recordor, vix aetatem Alexandri suffecturam fuisse reor adunum bellum. Et forsitan, cum et foederibus vetustis iuncta res Punica Romanae esset et timorpar adversus communem hostem duas potentissimas armis virisque urbes armaret, [et] simul Punico Romanoque obrutus bello esset. Non quidem Alexandro duce nec integris Macedonum rebus sed expertitamen sunt Romani Macedonem hostem adversus Antiochum Philippum Persen non modo cum clade ulla sed ne cum periculo quidem suo. Absit invidia verbo et civilia bella sileant: nunquam ab equite hoste, nunquam a pedite, nunquam aperta acie, nunquama equis, utique nunquam nostris locis laboravimus: equitem, sagittas, saltus impeditos, avia commeatibus loca gravis armis miles timere potest. Mille acies graviores quam Macedonum atque Alexandri avertit avertetque, modo sit perpetuus huius qua vivimus pacis amor et civilis cura concordiae.» (cap. 19)
A distanza di oltre duemila anni, le argomentazioni svolte da Tito Livio appaiono conservare una loro intangibile fondatezza: basata su dati oggettivi, storici. Argomentazioni che sanciscono come improponibile il confronto tra un Impero effimero – costruito letteralmente sulla sabbia, sorto dalla galassia delle monarchie e delle satrapie greco-orientali – e uno stato plurisecolare fondato come già detto sul principio della certezza del diritto, nonché sui concetti laici di virtus, fortitudo, disciplina, fides e concordia. L’essenza stessa del “sentire” di Tito Livio, in una comunione spirituale con la storia della sua Patria: una temperie che come detto rasenta l’osmosi.
Fondamentalmente, al di là del fascino esercitato dal personaggio, la figura di Alessandro Magno appare storicamente abbastanza sopravvalutata:
- a Gaugamela, anche smaccatamente favorito dagli errori dell’avversario, fu premiato dalla “buona sorte” ben oltre i suoi meriti;
- la campagna afghana, malgrado l’espediente di sposare la principessa Roxane (figlia di un “caudillo” della zona, uno dei capitribù locali), fu nel complesso piuttosto disastrosa: poco meno che “una marcia in armi in territorio ostile”, per riprendere un’efficace definizione proposta da Sir Arthur Wellesley, Duca di Wellington, sulle guerre anglo-afghane del XIX secolo;
- infine, edificò un impero talmente effimero che non resse nemmeno alla sua scomparsa (e morì giovane, come è noto): impero dilaniato dalla “Guerra dei Diadochi” (Πόλεμος τῶν Διαδόχων), una serie di conflitti combattuti nel periodo 322-281 a.C. tra i suoi generali che se ne disputavano il controllo.
Quell’elemento di fascino del personaggio emerge con chiarezza dalle pagine di Pompeo Trogo e di Curzio Rufo; pagine condite anche di tutta una sapiente aneddotica: l’aver avuto come precettore Aristotele, l’aver domato ancora giovanissimo il suo cavallo Bucefalo, il nodo di Gordio, il pianto dirotto sul corpo esanime dell’amico Clito, il matrimonio con la giovane e bellissima principessa straniera…
Un fascino a cui non fu immune neppure il mondo di Roma: come ebbe ad annotare Concetto Marchesi, “E anche i Romani – che pure avevano sotto gli occhi il prodigio del loro impero – dovevano subire il fascino del condottiero eccezionale alla cui fortuna e alla cui cupidigia pareva piccolo il mondo”.
Un fascino al quale Tito Livio ribatte in modo puntiglioso, da storico di classe cristallina quale è, dando alla sua prosa un respiro di secoli: «cum populi iam octingentesimum bellantis annum», a fronte del fatto che l’intera parabola di Alessandro copre un periodo pari a quello della durata della Prima Guerra Punica. E ancora: ottocento anni… impossibile non pensare che a distanza di alcuni decenni, Cornelio Tacito esprimerà un concetto totalmente analogo (Historiae, IV, 74), nell’ambito di una magistrale analisi politica e militare: «octingentorum annorum fortuna disciplinaque compages haec coaluit, quae convelli sine exitio convellentium non potest: sed vobis maximum discrimen, penes quos aurum et opes, praecipuae bellorum causae.» [Ottocento anni di fortuna e di disciplina hanno cementato questa struttura, che non può essere demolita senza la rovina di chi la demolisce. E il rischio maggiore tocca a voi che possedete oro e ricchezze, cause primarie di guerre.]
Infine potrà forse sembrare provocatorio, oltre che paradossale: ma come già intuito proprio da Tito Livio, un importante elemento della “fortuna postuma” di Alessandro (ed indubbia componente del suo perdurante, millenario fascino) potrebbe essere consistita nell’essere morto giovane. Sia detto per inciso, con un salto attraverso i secoli sembra potersi individuare – almeno in parte – qualche interessante analogia con le vicende di Carlo XII di Svezia (1682-1718); il giovane, colto e raffinato sovrano scandinavo condusse una prima serie di brillanti – e fortunate – campagne militari: a Narva (1700) colse la sua Gaugamela, anche con una notevole dose di buona sorte; dopo un successo – pur decisamente meno netto – riportato in una successiva campagna a Golovchin (1708), colto da una sorta di sindrome dell’infallibilità peccò di “hybris”, cosa per la quale venne punito dagli Déi (che sempre accecano coloro che vogliono perdere): adottando una serie di scelte totalmente errate che culminarono infine con la decisione dell’alleanza con l’atamano cosacco Ivan Mazzeppa e di intraprendere la disastrosa campagna ucraina, decisioni che furono la premessa alla successiva e definitiva disfatta contro le truppe dello Zar Pietro il Grande (1709). Quegli stessi Déi che furono magnanimi con Alessandro, a cui venne invece risparmiata l’onta di una dolorosa – ed irrecuperabile – Poltava.
Un’ultima annotazione: da un punto di vista politico e militare, l’eredità di Alessandro Magno appare nel complesso abbastanza trascurabile, mentre ovviamente del tutto diverso è il discorso dal punto di vista culturale; del concetto di “Cesarismo” si è già accennato precedentemente, mentre appare opportuno sottolineare che il concetto di “Alessandrinismo” afferisce più propriamente al campo della produzione artistica e letteraria.
Prosegue con “La satira, che è tutta nostra…”
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta.
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”.
- Tacito, analisi politica e passione tragica.
- Lucrezio, ragione e angoscia.
- Cicerone, tra otium e negotium.
- La crisi dell’arte retorica.
- Alcuni storici minori.
- Petronio, arguzia ed estetica.
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica.
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione

Lascia un commento