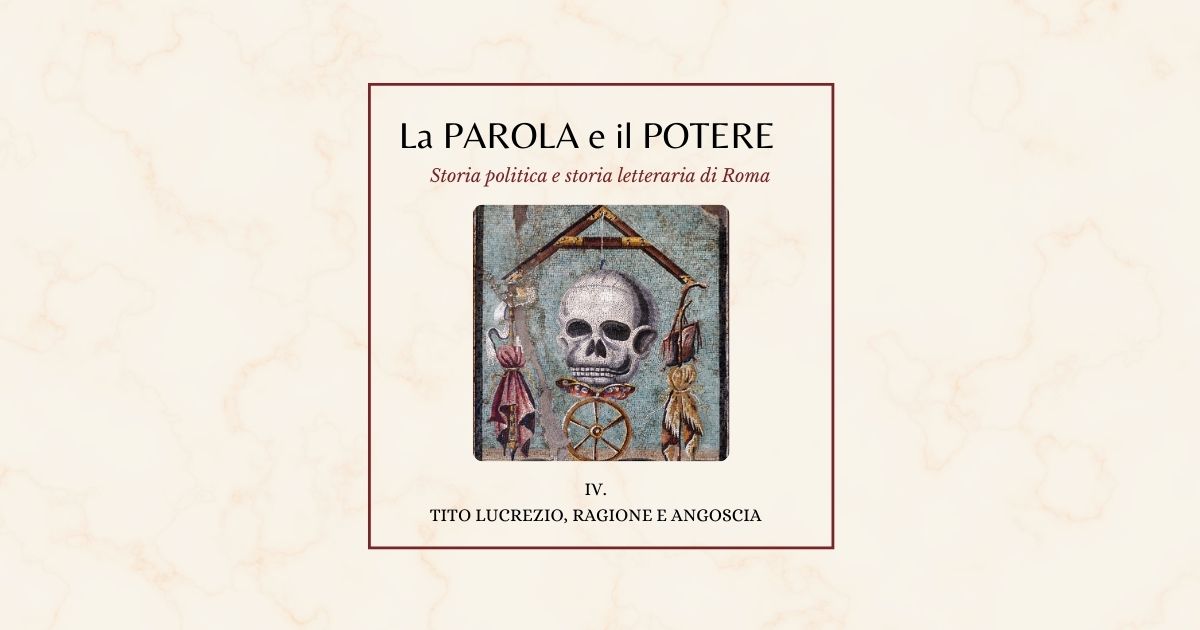Storia politica e storia letteraria di Roma
Il contributo che presentiamo oggi – quarto di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.
Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.
Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Alcuni storici minori
- Petronio, arguzia ed estetica
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
4. Tito Lucrezio, tra ragione e angoscia: «patriai tempore iniquo»
Storia politica e storia letteraria: proprio il già citato e famoso passo lucreziano «patriai tempore iniquo» (De rerum natura, I, 49) è il paradigma di come un quadro storico-politico possa condizionare la produzione letteraria e trovarvi pieno riscontro. Anche in direzioni opposte, evidentemente: il grande poeta fa suo il messaggio epicureo e chiede a Venere una pace vera – chiedendo cioè alla dea di esercitare nel poema la funzione che ricopre nel mondo (portando pace e serenità) – poiché ritiene che in una fase tormentata della vita dello Stato, o della società, non sia possibile scrivere, e quindi esercitare la sua missione di poeta; al contrario (come si è visto) di come agì Sallustio, che si era ritirato a scrivere dopo aver lasciato la politica attiva dichiarando esplicitamente che scrivere di storia fosse ancora un modo per servire lealmente la Patria.
Tito Lucrezio è uno dei più grandi poeti della letteratura mondiale, di ogni epoca: in comune con Epicuro ha il suo vivere in un momento di crisi sociale e politica, ma la sua reinterpretazione del pensiero del filosofo rende conto di come dallo stesso tipo di crisi possano sorgere atteggiamenti diversi. Epicuro era vissuto nell’epoca successiva al crollo delle città stato greche (πόλεις), della loro cultura e società: il suo “vivi nascosto” (Λάθε Βιώσας) nasce dalla percezione del fatto che non ci può essere collaborazione tra il singolo ed il sistema; con la conseguenza che la singola persona si sente più individuo e meno cittadino.
L’arte di Lucrezio è quindi condizionata dal momento storico e politico (come da lui stesso esplicitato), ma non vi è riferimento a momenti o fatti contingenti perché il suo poetare esprime un messaggio universale, valido per gli uomini di tutte le epoche; tuttavia, nella sua opera si percepisce nettissima la conoscenza, e l’influenza della letteratura e storia di Roma: dall’età arcaica all’epoca presente.
Inoltre, l’elemento unitario del poema appare essere non la storia, ma il suo lavoro di poeta: la fatica di trasporre in lingua latina i concetti della filosofia greca (orgoglio che condivide – idealmente – con Marco Tullio Cicerone); l’intento didascalico suppone non solo una ricerca linguistica ma, nella consapevolezza della novità della sua opera, anche la necessità di rendere l’oggetto del suo messaggio meno ostico ed accettabile. La conoscenza, come medicina per l’anima: il poeta, come il medico che applica il miele sul bordo di un bicchiere all’atto di somministrare al bambino una medicina amara (I, 935-950)
Anche ciò non ti appaia insensato; ma come il medico quando tenta di dare al bambino il disgustoso assenzio prima spalma le coppe di dolce e biondo miele per ingannare l’età ingenua dei fanciulli fino alle labbra e intanto beva l’amaro succo dell’ assenzio e non sia presa con l’inganno ma piuttosto perché in tal modo guarita stia meglio, così io dunque, poiché questa dottrina filosofica appare per lo più dura per coloro a cui non è stata trattata e il popolo arretra inorridito da questa, ho voluto esporre la nostra dottrina con i termini eloquenti e suadenti della poesia e quasi cospargerla del dolce miele delle Muse. Se io potessi per caso trattenere il tuo animo in tale dottrina con i nostri versi finché tu comprenda fino in fondo di quali elementi è composta la natura delle cose.
Il testo in latino
«Id quoque enim non ab nulla ratione videtur; sed vel uti pueris absinthia taetra medentes cum dare conantur, prius oras pocula circum contingunt mellis dulci flavoque liquore, ut puerorum aetas inprovida ludificetur labrorum tenus, interea perpotet amarum absinthi laticem deceptaque non capiatur,
sed potius tali facto recreata valescat, sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtur
tristior esse quibus non est tractata, retroquevolgus abhorret ab hac, volui tibi suaviloquenti carmine Pierio rationem exponere nostramet quasi musaeo dulci contingere melle, si tibi forte animum tali ratione tenere versibus in nostris possem, dum perspicis omnem naturam rerum, qua constet compta figura.»
Sia detto per inciso: Epicuro aveva affermato che l’attività più importante per l’uomo non è poetare, ma filosofare; la contrapposizione con Lucrezio è evidente…
Ancora, il titolo riprende il “perí physeos” del filosofo (che si articolava originariamente in XXXVII libri, e di cui ci sono pervenuti solo frammenti) ma il sottotitolo «de fisica rerum origine vel effectum» esprime ben altro: non solo si parlerà dell’essenza del mondo, ma anche della nascita, della strutturazione pratica della materia, e della morte. Proprio un senso di fine cosmica permea infatti il poema: il che costituisce un’altra rimarchevole differenza con il “Maestro”, la cui filosofia era ispirata a un senso di non scalfibile ottimismo.
Lucrezio vive un intimo dualismo che ne ha contraddistinto l’interpretazione da parte degli studiosi (la dicotomia tra “poeta della ragione” e “poeta dell’angoscia”). La sua profonda componente pessimistica (estranea come detto a Epicuro) è legata a un senso di precarietà dell’esistere: ascrivibile forse alle sue vicende biografiche, ma la scarsità delle notizie disponibili ne rende ardua la lettura. Ciò che è noto della vita di Lucrezio deriva principalmente da quanto riporta San Gerolamo, nel «Chronicarium» (149, 20-26 H.), la cui fonte sembrerebbe risalire a un «De viris illustribus» (perduto), di Caio Svetonio.
«Titus Lucretius poeta nascitur. Qui postea amatorio poculo in furorem versus cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIIII.»
È possibile credere che Lucrezio si sia suicidato (anche se l’epicureismo rifiutava programmaticamente il suicidio, al contrario dello stoicismo): forse proprio per il non capacitarsi dell’impossibilità di raggiungere quelle verità delle quali era convinto, meno probabilmente per amore (pur tenendo conto della cupa disperazione che permea il finale del libro IV del poema). Come riporta Concetto Marchesi, “Lucrezio è uno di quelli che soffrono e vedono con esasperante lucidità i loro mali”; e ancora, “sapere di cosa si soffre non esclude il soffrire”. Più difficile invece credere che fosse pazzo, a maggior ragione per opera di un filtro amoroso («amatorio poculo») e che scrivesse in momenti caratterizzati da sprazzi di lucidità («intervalla insaniae»): in questo caso sembra aver avuto un ruolo preponderante una tradizione culturale a lui sfavorevole (così come nei confronti dell’epicureismo più in generale), prolungata anche dal cristianesimo, dopo l’influsso della cultura tradizionale romana.

Lucrezio, tra arcaismo e alessandrinismo
L’analisi del testo del poema offre una serie di spunti per meglio inquadrare la poetica lucreziana: nella quale convive un bipolarismo quasi dicotomico che costituisce una compiuta rappresentazione dell’età di passaggio e trasformazione (cultura, politica, sociale, letteraria) della società che fa da sfondo alla vita del poeta.
La lettura del proemio può essere assunta a paradigma: un «incipit» articolato, che termina virtualmente con il verso 150: dopo il proemio in quanto tale (vv. 1-43), viene proposto un riassunto dei temi che saranno toccati nell’opera (vv. 43-60); successivamente (vv. 62-105), Lucrezio esplicita il suo intento di cercare verità che dessero pace all’uomo, ponendosi antitesi con la «religio» ufficiale, termine che il poeta assimila al concetto di “superstizione” (con il ben noto episodio di Ifigenia, vv. 80-101); la conclusione del proemio contiene il manifesto del suo intento poetico: trascrivere in latino la filosofia greca (l’orgoglio dell’impresa, la consapevolezza delle difficoltà), secondo il principio del «miscere utile dulci» – secondo una nota espressione oraziana, Epistulae, II, 3, 343 – che porta ad un linguaggio mai scientificamente arido, ma popolato di immagini poetiche. Sembra opportuno sottolineare che nell’ultima parte parla diffusamente dei filosofi pre-socratici: si dimostra quindi profondo conoscitore della filosofia greca (così come della letteratura latina arcaica), con una postura di continuità rispetto al passato che si connota in netto contrasto con Epicuro che si diceva allievo solo di sé stesso.
L’invocazione a Venere sembra quella di un inno sacro (vv. 1-9): solo apparente è il paradosso della invocazione ad una dea tradizionale, poi parla degli effetti che la presenza di Venere ha sulla natura (vv. 10-20), mentre finora l’umanità è assente. Con il verso 20 introduce una preghiera personale, una richiesta di aiuto in senso spirituale: ciò rappresenta una novità rispetto alle preghiere tradizionali della letteratura latina delle origini (Carmen Saliare, Carmen Fratrum Arvialium), caratterizzate da richieste molto concrete e pratiche; preghiere “pratiche” si possono ritrovare anche in Ennio e in Tito Livio, una preghiera “politico-militare” è presente nel Carmen Saeculare di Orazio. Nella letteratura latina, un altro esempio di preghiera “personale” era stato quello di Valerio Catullo che implorava gli dei di guarirlo dalla passione amorosa (carme LXXVI); Lucrezio è l’unico che chieda di essere aiutato nello scrivere, e soprattutto chiede l’unica condizione sociale che permetta di scrivere: la pace, contrapposta al «patriai tempore iniquo». Nella scena di Marte e Venere (vv. 21-22) c’è l’inserimento dell’immagine con una tecnica tipica della poetica alessandrina, che convive senza iato con l’arcaismo di «belli fera moenera Mavors».
Inoltre, un testo sempre in bilico tra ricerca e sperimentazione linguistica e influssi di arcaismo, specchio di un’età di transizione tanto dal punto vista politico quanto da quello letterario: «daedala» è parola di nuova forgia, che esprime il significato di “variopinto”, perché finora gli elementi che avevano prevalso nel testo sono la luce e il colore; «Aeneadum» è termine che c’era già in Ennio (non a caso Pater Ennius), parola arcaica che si colloca non solo in contrapposizione con l’estetica alessandrina ma esprime inoltre un richiamo alla tradizione dell’origine stessa della stirpe romana. Venere madre di Enea, capostipite del popolo romano, ma «genitrix» e «alma» in senso lato: Venere fecondatrice, simbolo della continuità della vita e della lotta contro la morte (in collegamento con il già citato dualismo Marte-Venere).
Il termine «voluptas» è il corrispondente di «ἡδονή» greco (“edoné”, termine tipicamente epicureo); rispetto alla filosofia epicurea, l’uso di questo termine da parte di Lucrezio ha posto un quesito: la «voluptas» è il piacere catastematico della atarassia, oppure quello cinetico della vita che esprime il suo corso? Il critico francese Boyancé proporrà a tale riguardo una crasi, di particolare interesse proprio perché sembra tenere conto dell’habitat socio-politico lucreziano, affermando che questo termine esprima il piacere della calma del mondo dopo i rivolgimenti della vita (“piacere” sia per gli uomini che per gli dei, vedi verso 1). Quindi Venere genitrice, «natura naturans», ma nel contempo espressione del piacere che gli déi posseggono e a cui gli uomini aspirano.

Un esempio di ricercatezza stilistica è ben rappresentato dall’uso di anafore (utilizzo di parole identiche o che suonano nello stesso modo), allitterazioni e chiasmi; ancora, al verso 10 si può osservare un aggettivo riferito non al sostantivo, con l’ipallage del riferirsi sempre a ciò che è centrale (la primavera).
Oppure, termini nuovi come «navigerum» o «frugiferentis», che esprimono movimento vitale: in questi neologismi, la bivalenza di Lucrezio conoscitore del passato ma attento al presente, capace di conferire alle parole la forza delle immagini; «patefacta», apparsa all’improvviso; «genitabilis», atta a procreare: ogni parola è permeata di senso, una aggettivazione poeticamente splendida e sapiente. Una poetica a tal punto mirabile da portare un giorno Ugo Foscolo a desistere dal tradurre il De rerum natura. Nei vv. 7-9, le ultime parole esprimono il concetto che Venere agisce su tutti i quattro elementi principali quali erano stati individuati dagli antichi; la conclusione è il mare gioioso, sotto la luce: un passo che non può non richiamare a ben conosciuti versi di Dante Alighieri: “Lo bel pianeto che d’amar conforta faceva tutto rider l’oriente” (Purgatorio, I, 19-20).
La parola «lepos» (verso 15 e verso 28) è di derivazione alessandrina, esprime la grazia come frutto di meditazione, lungo lavoro preparatorio e non di getto: questo termine è in contrasto con quello di «decus» (tipicamente ciceroniano), come se Lucrezio sentisse che l’età di Cesare – con tutti i suoi rivolgimenti e sullo sfondo della guerra civile – avesse superato proprio quello stesso il concetto di «decus» quale era quello proposto dalla tradizione. Gli esempi di come ogni singola parola in Lucrezio rappresenti un concetto sono innumerevoli: «cupide» (verso 16 e verso 20): esprime la volontà di esplicarsi da parte della vita, mentre «sola» (verso 21) esprime la assoluta necessità di questa forza perché ciò avvenga; «dias» (verso 22): termine sacrale che esprime ancora il concetto di luminosità («in luminis oras», “le spiagge della luce”), mentre «pangere» (verso 25) esprime un concetto di fatica e quindi un collegamento con il labor limae dei «poetae novi» (“neòteroi”, νεώτεροι).
A partire dal verso 62, troviamo la prima lode di Epicuro: qui per un attimo scompaiono Roma e il suo «patriai tempore iniquo», così come capiterà nell’analogo passaggio del libro III. Un universalismo di cui è traccia anche nel «in terris» (al verso 63), che esprime il concetto che il suo messaggio è rivolto a tutti, e non solo a un’élite: infatti, è tutta l’umanità che è prostrata dalla superstizione; nel verso 74 utilizza un’immagine contadina per indicare che Epicuro ha seminato le menti (con il recupero in questo caso di una componente della cultura tradizionale latina), superando così le «flammantia moenia mundi» e conducendo l’umanità al cielo dopo aver sconfitto la superstizione: per inciso, quest’immagine sembra avere fortemente condizionato quella della «ingens silva» dell’umanità primitiva di G.B.Vico; «primus» esprime la priorità della ricerca razionale e del metodo scientifico, mentre «mortales» il senso tragico della vita e l’attenzione all’umanità; «religio» come oppressione, in contrapposizione con “pietas” che esprime il concetto di libera accettazione; «contra» (vv. 66-67), parola che, inserita alla fine di entrambi i versi, esprime il massimo della forza dell’opposizione: c’è il senso di un mondo che è tutto da scoprire, con tutte le sue leggi tutte da indagare e svelare. Come ovvio, Lucrezio sarà molto letto e commentato dagli autori della Nuova Scienza: la ragione unita al coraggio può esplorare l’immenso e l’infinito in uno slancio di “titanismo”, con la vittoria della ricerca che rende l’uomo simile agli déi.
Chiaramente, un’analisi puntuale del poema non è tra gli scopi di questa trattazione. Tuttavia, per concludere, un accenno al proemio del II libro (v. 1-19) che rappresenta un manifesto della poetica neoterica di Lucrezio: il termine «suave» è parola chiave, che richiama il concetto di «voluptas»; ma l’anima “romana” del poeta emerge ancora una volta, totalmente: dall’immagine del mare, che è tipicamente greca, passa a quella degli eserciti schierati. La parola «tenere» (verso 7) esprime il significato di possesso netto, mentre l’espressione «templa serena» (termine di origine sacrale presente anche nel Somnium Scipionis di Cicerone) ha il significato di spazio elevato; «edita» (al verso 8): esprime un possesso al quale si giunge con fatica, perché la conquista della serenità dottrinaria si consegue solo con uno sforzo e lotta intensi.
Lucrezio, l’amore come catastrofe dell’anima
L’amore in Lucrezio: un aspetto che merita una trattazione specifica. Una tematica, quella sentimentale, che non poteva non trovare posto nella sua opera: l’amore è componente imprescindibile dell’esistenza umana.
L’amore era stato analogamente presente prima nella produzione dei «poetae novi» e poi negli elegiaci dell’Età Augustea, fino a Ovidio. Tra i “neòteroi” (νεώτεροι), il più noto è senza dubbio Valerio Catullo: esponente di quella corrente di rinnovamento (letterario, e non solo) caratterizzata da una postura di individualismo, in cui era evidente la derivazione ellenistica e che aveva tra i suoi canoni: la «brevitas» (che traeva fondamento dal famoso motto «grande libro, grande male» [μέγα βιβλίον μέγα κακόν], un concetto centrale, che Callimaco aveva espresso negli Aitia già dal Proemio); il «labor limae» (ricercatezza e raffinatezza stilistica, come negli epigrammi frutto di solo apparente improvvisazione); la «doctrina» (un vasto patrimonio di conoscenza, che oggi si definirebbe umanistica).
Quel Catullo le cui poesie sono conosciutissime – e molto apprezzate – nelle quali l’alternanza delle pulsioni e delle fasi dello spirito, tuttavia, rende conto di una temperie talora quasi adolescenziale. Fra gli elegiaci, spicca in primo luogo la luminosità e sensualità della poesia d’amore di Sesto Properzio, le immagini di Cynthia proiettate nella sua anima: una donna colta, raffinata ed elegante, pienamente inserita nella società del suo tempo; bellissima e irraggiungibile, a cui il poeta dedica poesie come fossero lettere (anche in questo caso con fasi alterne); più sdolcinato appare, nel complesso, il poetare di Albio Tibullo: da Delia a Nemesis. Sicuramente complesso il caso di Publio Ovidio, autore di una produzione ricca e articolata: dalla mitologia delle “Metamorfosi” («Metamorphoseon libri XV») agli «Amores» e poi con la novità di un vero e proprio manuale di seduzione, la famosa «Ars amatoria». Tutto ciò risulta coerente con una generale rilassatezza dei costumi anche tipica dell’epoca, che alla fine costò cara al poeta, per decisione dello stesso Ottaviano Augusto. Le sue vicende biografiche – con il lungo esilio sulle rive del Mar Nero, al confine tra la Dacia e la Tracia: dove morì, senza mai aver potuto fare ritorno a Roma – ebbero grande incidenza anche sulla sua produzione letteraria; i «Tristia» ovviamente, specchio di una depressione che sarebbe via via trascolorata in autentica disperazione, e poi le «Epistulae ex Ponto». Proprio dalle lettere, si può trarre un’informazione molto particolare: il poeta, forse per disperazione deciso a mettere definitivamente fine al sogno di poter fare ritorno, comunica di aver appreso la lingua locale, e di essere diventato un “poeta getodacico”, scrivendo poesie – successivamente perdute – che gli valsero tuttavia anche un discreto successo (Epist., IV, 13).
Per completezza, c’è un altro esilio che ha lasciato una traccia profonda nella letteratura latina; il pensiero va al paesaggio livido della costa occidentale della Corsica, a quell’atmosfera da incubo che fece da sfondo alla vita di Lucio Anneo Seneca nel periodo 41-48 d.C.: un incubo talmente spaventoso da indurre l’intellettuale andaluso a tentare con ogni mezzo di conseguire una “riabilitazione” da parte del potere, anche a costo di scivolare in una riprovevole adulazione e piaggeria, come nel caso della «Consolatio ad Polybium» rivolta ad un potente liberto, favorito dell’Imperatore, in occasione della morte di un fratello. Un episodio questo che va a macchiare in modo indelebile le sue lezioni di filosofia e morale stoica.
Torniamo a Lucrezio. Forse meno noto – o considerato – da questo punto di vista, ma nel «De rerum natura» si può trovare uno dei più alti (e disperati) inni che l’essere umano abbia mai elevato all’amore, in qualsiasi epoca; concretamente, gli ultimi 250 versi del libro IV: la catastrofe dell’anima, il lamento estremo dello spirito divorato dal sentimento. Come è noto, non ci è pervenuto il trattato “Dell’amore” compilato dal suo maestro Epicuro: tuttavia, è lecito ritenere che quel testo fosse permeato del clima di atarassica pacatezza che caratterizza gli scritti ed il pensiero del filosofo greco. Nulla di tutto ciò è presente nel testo lucreziano. Quell’uomo che “sembra che sia stato tra le braccia di una donna e ne sia uscito come intossicato”: e allora ecco emergere “il ghigno sarcastico del fisiologo”; un commento autorevole, l’immagine proposta da Concetto Marchesi è sempre di rara efficacia.
Ma neanche l’analisi – che vuole farsi fredda e distaccata – che il poeta ci propone riesce a celarne il dramma interiore, ed a lenirne l’incoercibile disperazione. In margine alla lettura di quei versi (l’amore è la catastrofe con cui termina il Libro IV, così come la Peste di Atene è quella che conclude il Libro VI) rimane un interrogativo: o meglio, un arcano insolubile. Viene da chiedersi quale donna abbia mai potuto suscitare in un animo tanto eccezionalmente profondo un sentimento di quella caratura; e ancora: se lei lo abbia mai saputo, se lui si sia mai dichiarato direttamente; oppure se, al contrario, la straordinaria portata di quel sentimento amoroso si sia conservata incorrotta nel cuore del poeta anche dopo la fine – possibilmente traumatica – del loro rapporto. Un arcano millenario: un brivido di umanità che attraversa le epoche.

La Natura Matrigna, da Lucrezio a Leopardi
Tuttavia, un giudizio su Lucrezio non può essere funzione di come tratta singoli argomenti. Lucrezio è di un’immensità assoluta, la lettura della sua opera costituisce un’esperienza totalizzante, che avvince lo spirito nel sentire della comune dimensione umana. Da un lato, con il legittimo orgoglio di poeta, la fiducia nella scienza e nella capacità della mente dell’uomo; d’altro canto, l’immagine della Natura “matrigna” («tanta stat praedita culpa», V, 199), incentrata proprio sul concetto proprio della «culpa naturae» (V, 195-236):
[Ma se anche ignorassi quali sono i principi delle cose, questo oserei tuttavia affermare e sostenere grazie a molti altri fatti, che in nessun modo la natura delle cose è stata creata in nostro favore dagli dei: di tanti difetti è gravata. Anzitutto quanto spazio ricopre il grande slancio del cielo, di questo un’ampia parte occupano i monti e le selve (abitate) dalle bestie feroci, occupano le rocce e le desolate paludi e il mare che per ampio spazio separa le rive dei continenti. Poi quasi due terzi li portano via agli uomini il calore ardente e la caduta continua del gelo. Ciò che rimane di terra arabile, non di meno la natura con la sua potenza coprirebbe di rovi, se non le si opponesse l’energia umana, avezza, per sopravvivere, a gemere sulla zappa robusta e a fendere la terra premendo l’aratro. Se non chiamiamo alla nascita rivoltando col vomere le glebe feconde, lavorando il suolo della terra, (le messi) non potrebbero spontaneamente uscire nell’aria chiara; e tuttavia talvolta (i frutti) guadagnati con tanta fatica, quando già sulla terra (le piante) si coprono di fronde e tutto fiorisce, o li brucia con eccessivo calore il sole celeste, o li uccidono improvvisi acquazzoni e gelide brine e raffiche di vento sconvolgono con un violento turbinio. E poi perché la natura nutre e fa crescere l’orrenda stirpe delle bestie feroci, nemica della gente umana per terra e per mare? Perché le stagioni portano le malattie? Perché si aggira la morte prematura? E ancora il fanciullo, come un marinaio sbattuto dalle onde infuriate, giace a terra nudo, senza parola, privo di aiuto per la vita, non appena la natura, con dolorosi sforzi, lo ha fatto venire alla luce dal grembo della madre, egli riempie il luogo di vagiti lugubri, come è giusto per colui cui in vita tocca di attraversare tanti malanni. Ma al contrario crescono greggi, armenti e belve varie e non c’è bisogno di trastulli e per nessuno bisogna impiegare la voce carezzevole e balbettante dell’alma nutrice e non richiedono vesti diverse a seconda della stagione e insomma non c’è bisogno di armi e di alte mura per difendere le proprie cose dal momento che la terra stessa e la natura artefice delle cose generano in abbondanza tutto per tutti]
Il testo in latino
«Quod si iam rerum ignorem primordia quae sint, hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim confirmare aliisque ex rebus reddere multis, nequaquam nobis divinitus esse paratam naturam rerum: tanta stat praedita culpa. principio quantum caeli tegit impetus ingens, inde avidam partem montes silvaeque ferarum possedere, tenent rupes vastaeque paludes et mare, quod late terrarum distinet oras. inde duas porro prope partis fervidus ardor adsiduusque geli casus mortalibus aufert. quod super est arvi, tamen id natura sua vi sentibus obducat, ni vis humana resistat vitai causa valido consueta bidenti ingemere et terram pressis proscindere aratris. si non fecundas vertentes vomere glebas terraique solum subigentes cimus ad ortus. sponte sua nequeant liquidas existere in auras. et tamen inter dum magno quaesita labore cum iam per terras frondent atque omnia florent, aut nimiis torret fervoribus aetherius sol aut subiti peremunt imbris gelidaeque pruinae flabraque ventorum violento turbine vexant. praeterea genus horriferum natura ferarum humanae genti infestum terraque marique cur alit atque auget? cur anni tempora morbos adportant? quare mors inmatura vagatur? tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis navita, nudus humi iacet infans indigus omni vitali auxilio, cum primum in luminis oras nixibus ex alvo matris natura profudit, vagituque locum lugubri complet, ut aequumst cui tantum in vita restet transire malorum. at variae crescunt pecudes armenta feraeque nec crepitacillis opus est nec cuiquam adhibendast almae nutricis blanda atque infracta loquella nec varias quaerunt vestes pro tempore caeli, denique non armis opus est, non moenibus altis, qui sua tutentur, quando omnibus omnia large tellus ipsa parit naturaque daedala rerum.»
Come risulta evidente, il pessimismo cupo ed estremo di cui sono permeati questi versi appare anticipare di secoli la temperie spirituale che ritroveremo in Giacomo Leopardi, con il pessimismo storico e il pessimismo cosmico: di ciò è chiaro riscontro per esempio nelle Operette Morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, nonché nei Canti; in particolare, nel “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, dove chiarissima risuona un’eco e ispirazione lucreziana: “Nasce l’uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa; e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell’esser nato.” (vv. 39-44).
Ancora, altri esempi della vastità dell’orizzonte lucreziano. In una concezione biologica che prevede lo sviluppo e declino, la Natura stessa delle cose implica un percorso che porta ad una dissoluzione: non solo della vita umana, ma anche dei mondi più in generale, in una dimensione cosmica; la conclusione del II libro appare come pervaso da un senso di spossatezza, di fine incombente (vv.1120-1130; vv.1144-1174):
[Qui per tutte le cose deve arrestarsi il progresso vitale, qui natura con le sue forze raffrena la crescita. Tutti gli esseri che vedi ingrandire con ilare slancio e a poco a poco ascendere i gradini dell’età adulta, accolgono in sé più elementi di quanti ne emettono, finché il cibo si diffonde agevolmente in tutte le vene e finché non si sono ancor tanto dilatati da rimettere fuori molta sostanza e da perdere più di quanto la loro età non assimila. Poiché certo bisogna arrendersi al fatto che molti elementi defluiscono e sfuggono dai corpi; ma più ancora se ne devono aggiungere, finché hanno toccato il culmine dell’accrescimento. Allora un po’ alla volta l’età spezza le forze e il vigore adulto e scivola verso il declino. (…) Così dunque anche le mura del vasto mondo tutt’intorno espugnate rovineranno sgretolandosi in macerie. Il cibo infatti deve tutto ristorare rinnovellando, il cibo sorreggere, il cibo dare a tutto sostentamento: ma a nulla riesce, se le vene non tollerano quant’è sufficiente, né la natura fornisce quanto è necessario alla vita. E già ora la nostra età è fiaccata e la terra, sfinita dai parti, genera a stento piccoli animali, essa che ha generato tutte le specie e ha dato alla luce corpi giganteschi di belve. Non fu certo, io credo, una fune d’oro scesa dal cielo a calare dall’alto nei campi le stirpi mortali, né le crearono il mare né le onde che battono gli scogli, ma le generò la medesima terra che ora le nutre di sé. E anche le nitide messi e i vigneti ubertosi essa da principio creò spontaneamente ai mortali, essa donò i dolci frutti e i pascoli lieti; che ora si sviluppano a stento, cresciuti dalla nostra fatica, e logoriamo i buoi e le forze dei contadini, consumiamo il ferro, a pena sostentati dai campi: tanto sono avari di frutti e aggravano la nostra fatica. E ormai scuotendo il capo il vecchio aratore più spesso sospira che nel nulla son cadute le sue gravi fatiche, e quando l’età presente paragona ai tempi passati, loda sovente la fortuna del padre. Triste anche il coltivatore d’una vigna vecchierella e cascante incolpa il declino del tempo e impreca a questa età, e brontola che alla gente d’una volta, piena di devozione, era facile campare la vita su un piccolo podere, quando ciascuno aveva molto minor porzione di terra. E non capisce che tutte le cose lentamente si sfanno e s’avviano alla bara, spossate dal lungo cammino della vita.]
Il testo in latino
«Omnibus hic aetas debet consistere rebus, hic natura suis refrenat viribus auctum. Nam quaecumque vides hilaro grandescere ad auctu paulatimque gradus aetatis scandere adultae, plura sibi assumunt quam de se corpora mittunt, dum facile in venas cibus omnis inditur et dum non ita sunt late dispessa ut multa remittant et plus dispendi faciant quam vescitur aetas. Nam certe fluere atque recedere corpora rebus multa manus dandum est; sed plura accedere debent, donec alescendi summum tetigere cacumen. (…) Sic igitur magni quoque circum moenia mundi expugnata dabunt labem putris 〈que〉 ruinas. Omnia debet enim cibus integrare novando et fulcire cibus,〈cibus〉omnia sustentare, nequiquam, quoniam nec venae perpetiuntur quod satis est neque quantum opus est natura ministrat. Iamque adeo fracta est aetas effetaque tellus vix animalia parva creat quae cuncta creavit saecla deditque ferarum ingentia corpora partu. Haud, ut opinor, enim mortalia saecla superne aurea de caelo demisit funis in arva nec mare nec fluctus plangentes saxa crearunt, sed genuit tellus eadem quae nunc alit ex se. Praeterea nitidas fruges vinetaque laeta sponte sua primum mortalibus ipsa creavit, ipsa dedit dulcis fetus et pabula laeta; quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore, conterimusque boves et viris agricolarum, conficimus ferrum vix arvis suppeditati: usque adeo parcunt fetus augentque laborem. Iamque caput quassans grandis suspirat arator crebrius, incassum magnos cecidisse labores, et cum tempora temporibus praesentia confert praeteritis, laudat fortunas saepe parentis. Tristis item vetulae vitis sator atque 〈vietae〉 temporis incusat momen saeclumque fatigat, et crepat, antiquum genus ut pietate repletum perfacile angustis tolerarit finibus aevum, cum minor esset agri multo modus ante viritim. Nec tenet omnia paulatim tabescere et ire ad capulum spatio aetatis defessa vetusto.»
Lucrezio, tra esistenzialismo e «taedium vitae»
Oppure, gli itinerari dell’anima umana: tra esistenzialismo e «taedium vitae» (III, 1051-1065), in una temperie spirituale che ha conservato una sua diacronica attualità attraverso i secoli:
[Se gli uomini potessero, come è chiaro che sentono il peso che grava loro nell’animo e li tormenta e li opprime, conoscere anche le cause per le quali ciò avviene, e perché quel fardello di pena sussista immutato nel cuore, non trarrebbero la vita così, come ora per lo più li vediamo non sapere che cosa ciascuno desideri, e sempre cercare di mutare luogo nell’illusione di trovare sollievo. Spesso dai sontuosi palazzi irrompe all’aperto colui che in casa è stato preso dal tedio, ma tosto vi torna come chi s’è avveduto che fuori non c’è nulla di meglio. Di furia, spronando i cavalli, accorre alla sua fattoria ansioso come dovesse recare soccorso alla casa che brucia, ma appena toccate le soglie, ben presto sbadiglia o inerte si rifugia nel sonno e cerca l’oblio, o anche in gran fretta ritorna a vedere la città che ha lasciato]
Il testo in latino
«Si possent homines, proinde ac sentire videntur pondus inesse animo, quod se gravitate fatiget, e quibus id fi at causis quoque noscere et unde tanta mali tamquam moles in pectore constet, haut ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus quid sibi quisque velit nescire, et quaerere semper commutare locum, quasi onus deponere possit. exit saepe foras magnis ex aedibus ille, esse domi quem pertaesumst, subitoque revertit, quippe foris nilo melius qui sentiat esse. currit agens mannos ad villam praecipitanter, auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans: oscitat extemplo, tetigit cum limina villae, aut abit in somnum gravis atque oblivia quaerit, aut etiam properans urbem petit atque revisit.»
In conclusione, per Lucrezio sembrano potersi applicare le considerazioni espresse da Machiavelli nella già citata Lettera da San Casciano: un essere umano capace di parlare ai suoi simili – nelle varie epoche – come se fossero sui contemporanei; un dialogo muto, dove il poeta risponde alle nostre domande e inquietudini in nome di una comune condizione umana. Un poeta di grandezza incommensurabile, che decide di condividere le sue emozioni: una concezione didascalica dell’arte, e tuttavia capace di non annichilirla; il suo giustificato orgoglio di poeta, una capacità creativa che è un’inarrivabile, sapiente miscela di arcaismi di ricerca linguistica e di perfezione stilistica di stampo alessandrino: ancora una volta, quella perfezione talmente compiuta da far dimenticare se stessa, da sembrare frutto di improvvisazione o di estemporanea intuizione, piuttosto che del fine cesello del «labor limae».
Contemporaneo del poeta, Marco Tullio Cicerone ne revisionò i libri per la pubblicazione (postuma) dell’opera: per primo intuì che essa sarebbe stato un formidabile veicolo per la diffusione di una filosofia “di importazione” dal mondo greco, proprio grazie al mezzo artistico, affermando inoltre che essa era la sintesi tra ingegno umano e labor limae. Pur da “avversario”, osteggiando generalmente il medesimo labor limae visto come vuoto formalismo, Cicerone in questo caso rende omaggio all’arte vera di Lucrezio, alla straordinaria creatività del poeta: che la accuratezza stilistica può solo impreziosire ma non certo creare. “Avversari”, certo… Cicerone è figura apparentemente molto distante, se non antitetica, rispetto a Lucrezio: in realtà, ad accomunare i due grandi intellettuali e letterati di Roma vi è una profonda affinità umanistica. Il Somnium Scipionis può essere considerato il paradigma di questa saldatura con il De rerum:quell’immagine comune della terra in gran parte inospitale; un microcosmo piccolissimo, perso nella infinità dei mondi, solo in alcune zone abitato – e abitabile – dall’uomo: zone ubicate nelle fasce temperate (rispettivamente boreale e australe) che non sono in comunicazione tra loro…
Prosegue con “Cicerone, otium e negotium”
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta.
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”.
- Tacito, analisi politica e passione tragica.
- Lucrezio, ragione e angoscia.
- Cicerone, tra otium e negotium.
- La crisi dell’arte retorica.
- Alcuni storici minori.
- Petronio, arguzia ed estetica.
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica.
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione