Storia politica e storia letteraria di Roma
Il contributo che presentiamo oggi – terzo di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.
Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.
Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Alcuni storici minori
- Petronio, arguzia ed estetica
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
3. Cornelio Tacito: tra rigore storiografico e arte del racconto, tra analisi politica e lacerazione interiore
Cornelio Tacito: il rigore della storiografia, senza ira, animosità o faziosità («sine ira et studio» – Annales, I, 1; «neque amore […] et sine odio» – Historiae, I, 1). Il concetto cardine di Tacito è «potestas»; la sua è storia profondamente politica, vista da un’angolazione morale: potrà conservare il potere chi non è (più) degno?
Tacito è anche grande maestro dell’analisi psicologica: la solitudine dell’uomo davanti al potere (Historiae, I, 21; Annales, VI, 6), la psicologia della folla (Historiae, I, 69; I, 83), volubilità e inettitudine del volgo (Historiae, IV, 37-38), le bassezze della delazione (Annales, IV, 30; Historiae, I, 2). Ancora, il rifiuto della pratica del suicidio come forma di estrema protesta politica di fronte all’oppressione (atteggiamento che era tipico dello stoicismo): «Sciant quibus moris est inlicita mirari, posse etiam sub malis pricipibus magnos viros esse» (La vita di Agricola, XLII), “sappiano coloro che hanno per costume ammirare ciò che non è lecito, che si può essere uomini grandi anche sotto cattivi príncipi”.
Tacito è anche storico “pittore” che, pur senza indulgere mai a leziosità o iperboli e mantenendo viceversa l’essenzialità del rigore storiografico, ci propone immagini di straordinaria intensità e bellezza; tra esse, si possono per esempio annoverare:
- la visione dell’Oceano dell’estremo nord fatto come di un’acqua più densa, uno scenario grigio e inospitale, un mare pigro e invalicabile (Germania, XLV):
«Trans Suionas aliud mare, pigrum ac prope inmotum, quo cingi cludique terrarum orbem hinc fides, quod extremus cadentis iam solis fulgor in ortus edurat adeo clarus, ut sidera hebetet; sonum insuper emergentis audiri formasque equorum et radios capitis adspici persuasio adicit. Illuc usque, et fama vera, tantum natura.»
[Al di là dei Suioni c’è un altro mare, stagnante e quasi immobile, che cinge e chiude la terra: lo si crede perché l’estremo rifulgere della luce del sole al tramonto dura fino all’alba, in un chiarore tale da offuscare le stelle; la credenza popolare aggiunge che, al sorgere del sole, si ode un suono e si vedono le forme dei suoi cavalli e i raggi attorno al suo capo. Fin là arriva il mondo, e la notizia è vera]
- la descrizione della fase notturna della seconda Battaglia di Bedriaco nella guerra civile dell’anno 69 d.C. (Historiae – III, 23): la luna, che illumina d’improvviso il teatro di uno scontro sanguinoso, quelle ombre che si allungano dalle spalle delle legioni dei Flavi; un’apparentemente semplice annotazione tattica, su un evento cruciale nel determinare l’esito della battaglia, ma che nella prosa tacitiana disegna un quadro di arte pura:
«neutro inclinaverat fortuna donec adulta nocte luna surgens ostenderet acies falleretque. sed Flavianis aequior a tergo; hinc maiores equorum virorumque umbrae, et falso, ut in corpora, ictu tela hostium citra cadebant: Vitelliani adverso lumine conlucentes velut ex occulto iaculantibus incauti offerebantur»
[non si profilava ancora per nessuno la vittoria, senonché a notte inoltrata, si leva la luna a illuminare le due schiere con la sua ingannevole luce. Favoriti i Flaviani, che l’avevano alle spalle: s’allungavano, per loro, le ombre di uomini e cavalli e, scambiando le ombre per corpi, il tiro nemico era troppo corto; i Vitelliani, investiti in pieno dalla luce, si offrivano scoperti a chi colpiva stando, per così dire, nascosto]
- sempre a Bedriaco: passata la notte, dopo le parole di Marco Antonio Primo a incitare i suoi uomini, il saluto del sole nascente all’alba da parte dei soldati della III Legione, che essendo rimasti a lungo in Siria ne avevano assorbito i culti e i costumi («undique clamor, et orientem solem [ita in Syria mos est] tertiani salutavere», Historiae – III, 24). Così si chiude il capitolo.
Un peculiare aspetto della “arte pittorica” di Tacito è inoltre rappresentato da una inarrivabile capacità di delineare ritratti femminili; nella scelta dei personaggi non fa distinzioni di censo o etnia, amici o nemici di Roma: si possono così incontrare la principessa Thusnelda (Annales, I, 55), la schiava Epicari (Annales, XV, 57), la regina Boudicca (Agricola, XIV-XVI; Annales, XIV, 29-39); oppure quella ancella senza nome e senza volto, che fugge spaventata dalla stanza della sua «Domina» all’arrivo dei sicari dell’Imperatore: «tu quoque me deseris?» (Annales, XIV, 8), “anche tu mi abbandoni?” Ritratti che lasciano un’impressione profonda: dove i lineamenti fisici sono praticamente assenti, mentre in essi è invece fortissima l’eco dell’anima di queste donne.


Come si diceva, una storia politica permeata di sdegno morale, vissuta come lacerazione interiore; il disgusto umano verso il servilismo nelle sue forme peggiori, con lo spettacolo della «libido adsentandi», “la voluttà di essere servi” (Historiae, I, 1); il potere che diventa tirannide, il consenso che diventa acquiescenza. Storia popolata di uomini e donne, di moltitudini e popoli. Cornelio Tacito è profondo – e disincantato – conoscitore della natura umana; ciò che osserva non lo induce all’ottimismo (Agricola, III):
«natura tamen infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala; et ut corpora nostra lente augescunt, cito extinguuntur, sic ingenia studiaque oppresseris facilius quam revocaveris: subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo, et invisa primo desidia postremo amatur»
[tuttavia la stessa fragilità della natura umana rende l’effetto della cura più lento del diffondersi della malattia; e come per i nostri corpi è lenta la crescita, ma rapida la dissoluzione, così è tanto più facile soffocare l’intelligenza e le sue opere che non rianimarle: perché s’insinua nell’animo la dolcezza dell’inerzia, e l’inattività, da principio faticosa, diventa alla fine gradevole].
In queste parole di Tacito, torna l’eco di quanto aveva scritto già Tito Livio un secolo prima: «ad haec tempora, quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus, perventum est» (I, 1), “finché non siamo giunti all’epoca presente, dove non possiamo tollerare né i nostri vizi, né i loro rimedi”.
Modernità di Tacito: tra sovranità limitata e «realpolitik»
Cornelio Tacito, che scrive nell’epoca in cui l’Impero Romano è arrivato non solo alla sua massima estensione territoriale, ma anche all’apogeo della sua potenza sociale, militare, politica ed economica (con la vittoriosa campagna mesopotamica di Marco Ulpio Traiano, nell’anno 117 d.C.), è anche maestro di “realpolitik”: con le parole pronunciate dal generale Petilio Ceriale (Historiae, IV, 73-74) ci lascia uno dei più efficaci e compiuti manifesti programmatici di gestione della politica internazionale. Nell’enunciazione del principio della sovranità limitata come strumento di protezione della pace e della sicurezza – a medio e lungo termine – c’è tutto il senso profondo di un’interpretazione politica matura e di straordinaria modernità: un messaggio che arriva incorrotto nella sua portata fino a noi, uomini del XXI secolo.
Ma c’è di più: il rifiuto politico e la condanna degli eccessi dell’imperialismo (che possono rappresentare un pericolo mortale per l’impero) risuonano nelle parole del condottiero dei Caledoni, Calgaco, che parla ai suoi guerrieri alla vigilia della Battaglia del Monte Graupio (Agricola, XXX, 7), così come in quelle di Boudicca, Regina degli Iceni, prima della Battaglia di Watling Street (Annales, XIV, 35). Tacito è pieno interprete dello spirito imperiale di Roma, certamente; tuttavia, nella monografia «De situ et origine Germanorum» (98 d.C.), un saggio etnografico e sociologico che rappresenta un «unicum» e novità assoluta nella letteratura antica, il grande storico da un lato mette in guardia da genti che non conoscevano il costume della pace, per le quali le armi rappresentavano sia capi d’abbigliamento che doni nuziali, alle quali era sgradita la quiete e sembrava ignavia e viltà guadagnarsi col sudore ciò che può conquistarsi col sangue («sudore adquirere quod possis sanguine parare», Germ. XIV); d’altro canto, rende omaggio all’etica e postura teutoniche: «nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur» (Germ. XIX), “nessuno presso di loro si ride dei vizi, né corrompere ed essere corrotto si dice vivere secondo i tempi”; popoli e tribù implacabili nemici di Roma, però genti dove le regole morali valgono più delle leggi («plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges»), dove capi e comandanti militari vengono scelti unicamente sulla base del loro valore e qualità morali (Germ. VII), dove il rispetto e la assoluta fedeltà reciproca sono alla base del legame di coppia e dell’educazione dei figli (Germ. XVIII-XX).
Lo storico politico e la «questione tedesca»
Proprio in questa monografia – dove tiene idealmente a battesimo “la questione tedesca” – emerge già tutto il valore dello “storico politico”: l’intuizione del problema, diacronico attraverso i secoli, della aspirazione egemonica della Germania nella geo-politica mondiale fa di Cornelio Tacito uno dei più grandi storici di tutti i tempi. Nelle sue parole, risuona come un accorato grido di allarme:
«Sescentesimum et quadragesimum annum urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum audita sunt arma, Caecilio Metello et Papirio Carbone consulibus. Ex quo si ad alterum imperatoris Traiani consulatum computemus, ducenti ferme et decem anni colliguntur: tam diu Germania vincitur». (Germ., XXXVII)
[La nostra città aveva seicentoquaranta anni di vita, quando per la prima volta, sotto i consoli Cecilio Metello e Papirio Carbone, si sentì parlare delle armi dei Cimbri. Se calcoliamo da allora fino al secondo consolato dell’imperatore Traiano, si sommano quasi duecentodieci anni: da così tanto tempo stiamo vincendo contro la Germania]
«Maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare fortuna maius potest quam hostium discordiam» (Germ., XXXIII).
[E prego che così continuino in quei popoli, se non l’amore per noi, almeno l’odio fra loro, dal momento che, mentre si profila un minaccioso destino sull’impero, ormai la fortuna nulla di meglio può accordarci che la discordia fra i nemici]
Un’intuizione – ed una percezione – mirabili: ben prima del “lebensraum” e della “Kultur”, di Kant, Fichte e Hegel; e prima di Federico il Grande (“drang nach osten”), Otto von Bismarck, Helmuth von Moltke il Vecchio (Sadowa, 1866; Sedan, 1870) e Paul von Hindenburg (Tannenberg, 1914). Un’intuizione, quella di Tacito, che ci fornisce inoltre una chiave di lettura e interpretazione della dinamica e gestione di guerre lunghe e che risulta arduo “vincere”; c’è come un senso di sottile angoscia, in quel «proximis temporibus triumphati magis quam victi» (Germ. XXXVII): un sentimento che nel profondo dell’anima romana si proiettava tanto sulla frontiera renana quanto sul fatale «limes» mesopotamico; e che nei secoli avrebbe visto in successione, tra gli altri: Varo e Germanico, Druso e Flavio Giuliano, Crasso e Traiano, Settimio Severo e Licinio Valeriano… concetti diacronici, nell’arco dei secoli e millenni: dal Reno ed Eufrate, fino al XXI secolo.
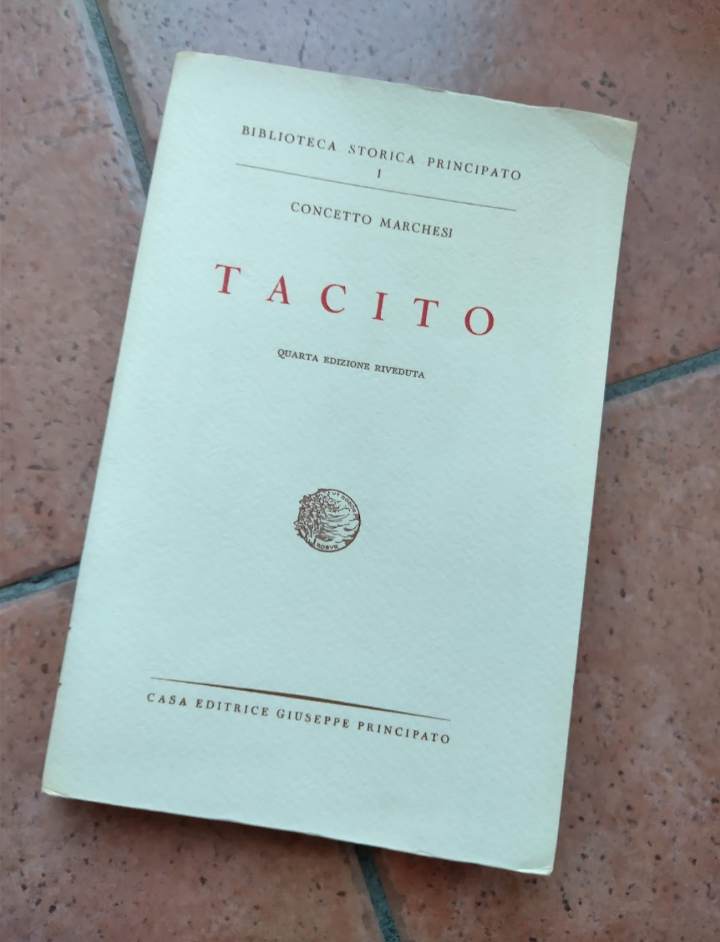
La consapevolezza dell’iniquità degli eccessi dell’imperialismo (una postura che, oltre a rappresentare un pericolo per la vita stessa dell’Impero, tradisce inoltre il principio della profezia virgiliana [«Tu regere imperio populos, Romane, memento: hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos», Aen., VI, 851-3]) e lo sdegno morale che ne deriva, oltre che nelle pagine di Cornelio Tacito si avvertono analogamente nei versi di Decimo Junio Giovenale; anche lui tratta di eccessi e vessazioni nei confronti dei popoli conquistati (VIII, 121-124):
«curandum in primis ne magna iniuria fiat fortibus et miseris, tollas licet omne quod usquam est auri atque argenti: scutum gladiumque relinques, et iaculum et galeam. spoliatis arma supersunt.»
“guardiamoci dall’infliggere pesanti offese a uomini forti e colpiti da sciagura, quando sarà stato tolto loro ciò che ancora avevano di oro e argento, essi avranno sempre scudo e la spada, giavellotto ed elmo; a chi è stato tolto tutto, restano le armi”.
Come poeta Giovenale non vuole parlare di miti ormai vecchi e risaputi: l’uomo – nelle sue diverse posture e manifestazioni e nelle varie situazioni che la vita propone – sarà l’oggetto del suo canto (il concetto di «farrago», Sat. I, 85-86). E, ugualmente, proprio del suo sdegno morale: nella Satira I (79-80), che rappresenta di fatto il proemio e “manifesto programmatico” della sua opera, ci dà la misura dell’intima sofferenza da cui scaturisce la sua poesia: «si natura negat, facit indignatio versum» [“se la natura non vuole, mi fa i versi la collera”].
Nella letteratura antica troviamo altri momenti in cui l’animo dei vincitori si apre all’ascolto delle ragioni e della voce dei vinti: per esempio è traccia di ciò in versi di Omero o di Euripide (che rappresentano inoltre autentiche vette artistiche). Ma in questo caso, in Tacito e Giovenale, c’è di più. La disponibilità, o meglio l’esigenza sentita, di dare voce ai vinti suppone una posizione di maturità e di avanzata consapevolezza in termini di “senso dello stato” (quell’unitarietà che il mondo greco non ha mai conosciuto): dei suoi compiti, e della sua parabola proprio nella sua evoluzione storica. Non è un vezzo elegante, o cultura da salotto: riflette al contrario un’analisi che si colloca in una dimensione sociale, politica militare e economica; e che trova spazio nelle pagine di uno storico così come nei versi di un poeta, con la denuncia dei soprusi dei veterani di Camulodunum e Verulamium così come di quelli di Verre e di Dolabella: con la stessa consapevole sofferenza.
Sempre nei versi di Giovenale, abbiamo inoltre l’espressione della crisi di tutta una classe dirigente – patrizia, ma anche equestre – che sembrava non essere più in grado di esercitare il potere ereditato dai suoi antenati: ancora nella Satira VIII (vv. 39-52), troviamo una fiera invettiva nei confronti di una nobiltà degenere che si vanta dell’eredità del sangue di Druso, mentre ormai solo dai ceti popolari (anche i più umili) provengono non solo quegli avvocati o giureconsulti che tutelano gli interessi di patrizi ignoranti, ma anche quei legionari che vigilano la frontiera dell’Eufrate. L’Eufrate, certo: la percezione, fatale attraverso i secoli, del «limes» della Mesopotamia era vissuta come un incubo da tutta la classe intellettuale romana, non solo dai politici o dagli storici.
La disfatta di Carrhae in Oriente (9 giugno 53 a.C.) sembra avere lo stesso valore e significato di Teutoburgo in Germania. Il senso di un incubo che perdura, le insegne perdute, le legioni massacrate da Surena e da Arminio: «crassiana clade» [strage crassiana], si legge nelle pagine di Plinio il Vecchio (Nat. Hist. VI, 18, 47), e di autentico massacro è pieno riscontro anche in pagine di autori greci come Plutarco (Vita di Crasso, 17-33) e Cassio Dione (Hist. Rom., XL, 12-30); della sorte della “legione perduta” di Marco Licinio Crasso è inoltre testimonianza in Orazio, con impattanti accenti rancorosi da cui traspare un irrisolto lacerante: i superstiti di Carrhae vengono definiti come veri e propri indegni disertori (Odi, III, 5, 5-12).
L’umanità tra «disciplina» e «fatum», «aruspicina» e «fortuna»
Infine, Tacito è storico di eccezionale modernità: non solo ha una ineguagliabile capacità descrittiva, ma oltre a riportarci le vicende storiche ne investiga le cause e cerca di interpretarle; e se è vero che appare dominato dalla convinzione che un destino supremo ed immutabile domini le vicende umane («quae fato manent, quamvis significata, non vitantur», Historiae, I, 18; «nihil arduum fatis», Historiae, II, 82), sempre nelle Historiae (I, 4) in precedenza aveva distinto tra gli avvenimenti che dipendono spesso dal caso e le loro cause razionali, cioè le loro connessioni causali («ut non modo casus eventusque rerum, qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio enim causaque noscantur»); secondo l’interpretazione proposta da Concetto Marchesi, questo orientamento sembra escludere un determinismo fatalistico:
“La causa non implica la necessità del fatto storico, ma la sua attuabilità: vale a dire, lo storico può ricercare e trovare le condizioni che hanno reso possibile un fatto, il quale poteva anche non accadere, ma non poteva accadere senza quelle determinate condizioni”.
Allo stesso modo, la conquista militare e l’impero stesso sono il prodotto di otto secoli di «fortuna disciplinaque» (Historiae, IV, 74), dove la «disciplina» è il complesso delle cause e la «fortuna» è il complesso degli eventi (espressione di una sorte cieca che può sfavorire o favorire, in modo del tutto afinalistico): la disciplina è stata la causa che ha reso possibile, non necessaria, la fortuna dell’Impero Romano. Più avanti, negli Annales (VI, 22), rinnoverà tuttavia un dubbio che non sa risolvere:
«Sed mihi haec ac talia audienti in incerto iudicium est fatone res mortalium et necessitate immutabili an forte volvantur»
[Quanto a me, nell’ascoltare tali e simili fatti, sono incerto nella valutazione se le vicende dei mortali si snodino secondo il destino ed una necessità immutabile o in base al caso].
Ma l’interpretazione forse più moderna della grandezza di questo storico è quella proposta dallo studioso francese Alain Michel (rif. “Tacito e il destino dell’Impero”, 1966), che richiamando quando espresso già da Giovanni Battista Vico afferma che nella concezione della storia in Tacito “la storia è un terribile incontro della filosofia con la sociologia”.

La parabola letteraria e storiografica di Tacito, in parallelo con la sua biografia: il cursus honorum iniziato all’epoca dei Flavi (Historiae, I,1), arrivato poi a pieno compimento sotto Nerva e Traiano; dal Dialogus de oratoribus agli Annales, passando per le opere monografiche (Germania e Agricola) e per le Historiae; dalla concinnitas di sapore ciceroniano del Dialogus alla «incondita ac rudis vox» (Agr., III) con cui sente di poter tornare ad esprimersi dopo la fine dell’incubo del potere di Domiziano, allo stile delle opere della maturità. Uno stile ineguagliabile, ed inimitabile; secondo la magistrale interpretazione di Concetto Marchesi, in Tacito “ogni frase è un’idea: e ogni parola è un organo vitale nel periodo. […] Il lenocinio della parola non c’è più, essa è tutta imbevuta di senso”.
La percezione dei limiti della conquista: tra numismatica e politica, storiografia e poesia
L’espansione e la conquista, dalla repubblica all’impero: tra orgoglio e inquietudine, dubbi e trionfi, sconfitte e incertezze. Anche elementi di numismatica, a corredo dell’interpretazione della produzione artistico-letteraria di pari passo con gli eventi storici:
- «Roma resurgens», si legge sulle monete fatte coniare da Tito Flavio Vespasiano: questo motto appare coerente con la temperie di cultura e gusto neoclassico che accompagnava l’azione del capostipite della dinastia dei Flavi, anche con l’attuazione di una serie di riforme volta al recupero dell’integrità sociale, politica ed economica dello Stato dopo le scelleratezze dell’epoca di Nerone e dopo la guerra civile dell’anno 69 d.C.;
- «Germania pacata», il motto che recano le monete fatte coniare da Marco Ulpio Traiano nel 98 d.C., celebrando il trionfo decretatogli per le vittorie sul fronte renano: ma nello stesso anno, come ricordato, Cornelio Tacito scrive: «tam diu Germania vincitur» (Germ. XXXVII), e poi «proximis temporibus triumphati magis quam victi sunt» (ibidem, XXXVIII);
- «Dacia victa»(102 d.C.): dopo la prima campagna in Dacia; qualche anno dopo, con la seconda campagna e il suicidio di re Decebalo (106 d.C.), la Dacia sarà definitivamente provincia dell’Impero;
- «Armenia et Mesopotamia in potestatem populi romani redactae» (115-116 d.C.): questo il motto delle monete dopo la campagna contro i Parti, in occasione del trionfo (postumo) decretatogli da Publio Elio Adriano; le legioni dell’Optimus Princeps, dopo aver disceso in doppia colonna il corso dell’Eufrate e del Tigri, avevano conquistato Ctesifonte ed erano successivamente entrate a Babilonia: una vittoria che non poteva considerarsi definitiva, e non solo per la repentina morte di Traiano (8 agosto 117 d.C.).
La scelta stessa delle parole è illuminante: la Dacia «victa» resterà stabilmente provincia dell’Impero per oltre un secolo (fino alla definitiva ritirata sul Danubio decisa dall’imperatore Aureliano nel 271 d.C.); al contrario, così come la vittoria sui Germani non poteva essere definitiva (Arausio, Campi Raudii, Aquae Sextiae Teutoburgo, Idistaviso e Vallo angrivariano, Argentoratum), altrettanto non avrebbe potuto esserlo mai quella sui Parti; Carrhae ed Edessa videro le sconfitte rispettivamente del triumviro Marco Licinio Crasso (53 a.C.) e dell’imperatore Publio Licinio Valeriano (260 d.C.); Marco Ulpio Traiano e – dopo di lui – Lucio Vero (166 d.C.), Settimio Severo (198 d.C.) e Gaio Galerio (298 d.C.) conquistarono e misero a ferro e fuoco Ctesifonte. Per inciso, l’ultimo imperatore a sconfiggere il secolare nemico sasanide sotto le mura della sua capitale, sulle rive del Tigri, sarebbe stato Claudio Flavio Giuliano (29 maggio 363 d.C.), al culmine della Campagna Mesopotamica: tuttavia, malgrado il netto successo nella battaglia campale, all’indomani della vittoria il giovane Cesare dovette poi dare l’ordine di risalire verso settentrione, nell’impossibilità di cingere d’assedio la città. Come ben noto, Giuliano sarebbe poi caduto in combattimento meno di un mese dopo: a Maranga, sulla strada per Samarra (26 giugno 363 d.C.). Per Roma, si chiudeva definitivamente un’epoca: Gioviano, rapidamente eletto quale nuovo Augusto, stipulò una altrettanto frettolosa pace con Sapore II, di fatto barattando la salvezza di ciò che rimaneva delle truppe imperiali con il definitivo ritiro dalla Mesopotamia.
Ma facciamo un passo indietro. La ritirata di Traiano – che si trovò a dover fronteggiare una serie di rivolte, anche orchestrate ad arte da suoi nemici interni, in Palestina, Egitto, Siria e Cirenaica – all’indomani della vittoria che aveva portato l’Impero alla sua massima espansione territoriale (portando le legioni di Roma fino alle rive del Mar Caspio e del Golfo Persico), sembra rimandare alla memoria il «Britannia perdomita et statim missa» di Cornelio Tacito (Historiae, I, 2): malgrado la campagna vittoriosa di Gneo Giulio Agricola in terra di Caledonia, all’epoca di Domiziano (quando le trireme della flotta imperiale avevano circumnavigato la Scozia e intravisto nella foschia il profilo delle Isole Shetland: la “ultima Thule”), il Vallo di Adriano (Vallum Aelium) avrebbe poi segnato per altri secoli il confine più settentrionale dell’Impero.
La consapevolezza della politica di conquista – nonché dei suoi limiti militari e logistici – risulta evidente anche nella produzione poetica: nella già citata Ode di Orazio (III, 5, 1-7) è ben chiara la portata e vastità dell’orizzonte su cui si muovono le legioni di Roma, dalla Britannia alla Mesopotamia. Prima di lui, in versi di Valerio Catullo troviamo l’espressione di concetti analoghi (carme XI); è interessante notare come – quasi paradossalmente – ciò avvenga in un carme in cui lo stesso Catullo dice sostanzialmente addio alla donna amata: da ciò si evince che se è ben vero che i «poetae novi» percorrono una via artistica nuova, anche distante dalla poetica e ideologia tradizionale, nella loro opera è chiaro riscontro di una profonda conoscenza ed influenza della storia di Roma.
Un’altra curiosità: accanto ai Parti provetti arcieri («sagittiferosve Parthos»), al gallico Reno e ai Britanni orribili ai confini del mondo («Gallicum Rhenum horribile aequor ultimosque Britannos»), Catullo fa menzione della “mollezza” di popoli orientali («in Hyrcanos Arabesve molles»); quest’immagine non può non rimandare a quella di “molli Rodiesi e unguentata Corinto” di cui scriverà Giovenale circa un secolo dopo («inbellis Rhodios unctamque Corinthon» – VIII, 113); a riprova proprio di una percezione durevole, attraverso le epoche e le stagioni politiche.
Anche nella prima Ecloga di Virgilio troviamo precisi riscontri dei confini geografici della potenza romana: «ante pererratis amborum finibus exsul aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim» (vv. 61-62), «alii sitientis ibimus Afros, pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen et penitus toto divisos orbe Britannos» (vv. 64-66), versi dove ugualmente i Britanni sono indicati come un popolo che vive in lande remote, ai confini del mondo. Prova dell’impatto – anche immaginifico – che la prima campagna di Giulio Cesare in Britannia (55-54 a.C.), con una spedizione che aveva portato le legioni di Roma verso i confini del mondo, è inoltre anche in questi versi di un’altra Ode di Orazio «serves iturum Caesarem in ultimos orbis Britannos» (I, 35, 29-30).
I confini del mondo torneranno infine ancora una volta, nei versi di Giovenale; il grande poeta satirico, che scrive nell’epoca di Traiano – quando come detto l’impero si appresta a giungere alla sua massima espansione territoriale e all’apogeo della sua potenza militare, politica ed economica – richiama l’aspirazione a fuggire dalle bassezze dell’abiezione morale e ipocrisia in cui si dibatte l’Urbe: non un viaggio verso le isole fortunate oltre il mare, avvolte in un orizzonte poeticamente indeterminato (come si legge per esempio negli Epodi oraziani), bensì oltre i confini geograficamente noti e delimitati della potenza romana. Così Giovenale, nell’incipit della Satira II (1-3): «Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem Oceanum, quoties aliquid de moribus audent, Qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt.» (“Che voglia di fuggirsene oltre le terre dei Sarmati o al di là dell’Oceano Glaciale, ogni volta che osano parlare di buoni costumi coloro che fingono di essere dei Curi e vivono invece in un perpetuo Baccanale!”).
Prosegue con “Tito Lucrezio, ragione e angoscia“
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Alcuni storici minori
- Petronio, arguzia ed estetica
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
