Storia politica e storia letteraria di Roma
Il contributo che presentiamo oggi – secondo di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua un percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.
Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.
Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Alcuni storici minori
- Petronio, arguzia ed estetica
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
2. Tito Livio e la sacralità della “res publica”
Il concetto cardine di Sallustio è quindi «concordia», l’unità di intenti tra le diverse componenti della società, presupposto ineliminabile per la saldezza dello Stato e per la salvezza della Patria: che è il contrario di quando «intra moenia atque in sinu Urbis sunt hostes» (BC, LII). Mentre il concetto cardine di Livio è «virtus», valore militare che presuppone doti di dirittura morale e saldezza d’animo: «integra atque immobilis virtus» (XXVI, 41); è nettissima un’eco polibiana nel concetto di «pristina virtus»: una miscela di disciplina austera, saggezza patrizia, moderazione del Senato e del popolo, un comportamento di giustizia e temperanza di cui Roma è esempio per gli altri popoli e che ne garantisce il primato morale, politico e militare («et facere et pati fortia Romanum est» [II, 12]).
«Sine lege nulla libertas» (XXXVII, 37): in queste parole di Tito Livio risuona l’orgoglio romano della certezza del diritto, il cui simbolo sono le leggi delle XII Tavole del 451-450 a.C., elaborate da un “comitato paritetico di esperti” – si direbbe oggi – e affisse nel Foro; la certezza del diritto, il principio del «dare iura gentibus» (XXX, 32) in nome di quella missione civilizzatrice che a Roma è stata affidata dagli dei stessi: «Urbs in aeternum condita» (Livio, IV, 4); «His ego nec metas rerum nec tempora pono: Imperium sine fine dedi» (Virgilio, Aen. I, 278-279); ma è un destino che Roma si è guadagnato con il suo comportamento e il suo valore: in questo concetto è l’eredità morale del messaggio contenuto negli Annales di Ennio («moribus antiquis res stat Romana virisque» [I, 390]), e cioè che lo Stato romano poggia sugli antichi costumi e sugli uomini.
Il concetto di «patavinitas» (ben noto), nel quale si è sempre riconosciuto: la moderazione, la sobrietà dei costumi, la «pristina virtus» alla quale si accompagna la «pristina paupertas».
Tito Livio, storico di classe cristallina, però va oltre; in una mirabile intuizione, tenta di dare una spiegazione razionale – quasi meccanicistica – della crisi dell’Impero (di cui intravede lucidamente i prodromi, nonostante esso fosse stato appena fondato): «iam magnitudine laboret sua», si legge nella Praefatio (par. 4) del «Ab Urbe condita», un impero che già soccombe sotto la sua stessa grandezza. Sia detto per inciso, in Sesto Properzio, grande poeta elegiaco dell’età augustea, rientrerà un concetto analogo, ma con esplicitato il ruolo della ricchezza acquisita:
«frangitur ipsa suis Roma superba bonis» (III, 13, 60)
[la superba Roma si spezza per la sua stessa opulenza]
Solo un secolo più tardi, infine, con accenti ben più sofferti che esprimono tutta la lacerazione interiore che è alla base del suo incoercibile impulso a poetare, Decimo Junio Giovenale parlerà della «obscaena pecunia» come sorgente primaria dei mali che attanagliano l’Urbe, a partire dalla corruzione dei costumi causata dai vizi di costumi stranieri e dalle mollezze del lusso: «Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit, et turpi fregerunt saecula luxu diuitiae molles.» (VI, 298-300).


L’intuizione del concetto di “Cesarismo”
L’impero, quindi: Tito Livio scrive della storia di Roma a partire dalle origini in un’epoca in cui ormai il Principato è una realtà politica dalla quale non si può tornare indietro, ma ha ben chiaro il dilemma del percorso politico che dalla repubblica consolare e senatoria – passando per le guerre civili – ha portato al potere assoluto e all’impero; i 19 libri nei quali trattava di Giulio Cesare sono perduti, ma dopo averne narrate le gesta chiudeva la trattazione con un interrogativo al quale non sa dare una risposta: se la nascita di Cesare sia stata un bene o un male per lo Stato («in incerto esse utrum illum nasci magis rei publicae profuerit an non nasci»), secondo un passo riportato testualmente da Lucio Anneo Seneca in Nat. Quaest., V, 18, 4.
Parole che sanciscono un arcano, non un dubbio: come magistralmente commentato da Concetto Marchesi, il massimo latinista italiano. L’arcano di un personaggio unico, che lasciò scritto che avrebbe mosso in armi per liberare il popolo romano dall’oppressione di una minoranza faziosa («ut populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret», De bello civili, I, 22,5). Per inciso, questo passaggio presenta delle spiccate analogie con quanto può leggersi nell’incipit delle Res Gestae Divi Augusti (o Index rerum gestarum), un resoconto redatto dallo stesso Ottaviano Augusto prima della sua morte e concernente le opere compiute durante la sua lunga parabola politica; così recita l’inizio di quello che è meglio conosciuto come “Testamento Ancirano”:
«Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi.»
“A diciannove anni, di mia iniziativa e con spesa privata, misi insieme un esercito, con il quale vendicai la Repubblica oppressa nella libertà dalla dominazione di una fazione.”
Tornando a Giulio Cesare, è inoltre impossibile non ricordare come proprio dal suo stesso nome siano derivati l’appellativo di “Cesare” poi sempre riferito agli imperatori di Roma, nonché in epoca posteriore “Zar” e “Kaiser”. Da ultimo, va considerato un protagonista della sua epoca che diede il nome a un fenomeno chiamato “cesarismo”, la cui influenza nel condizionare l’evoluzione politica di una società è stata oggetto di analisi attraverso i secoli, in una traiettoria che dai problemi interpretativi tratteggiati da Tito Livio arriva idealmente fino alle riflessioni introdotte da Antonio Gramsci nelle “Note sul Machiavelli”, nel terzo tomo dei Quaderni dal Carcere.
L’ombra di Machiavelli, il senso di un umanesimo condiviso
Conseguentemente, proprio l’ombra di Machiavelli si allunga su queste riflessioni: il ricordo di una lettura antica, a fare idealmente a ponte tra le epoche e riproponendo una temperie spirituale di umanesimo condiviso attraverso secoli e millenni. La lettera a Francesco Vettori, scritta dall’esilio a San Casciano nel dicembre 1513:
“Con questi io m’ingaglioffo per tutto dí giuocando a cricca, a trich-trach (…) Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro.”
Sembra di vederlo, a lume di candela, chino sui primi libri del “Ab Urbe condita” di Tito Livio, intento ad annotarne interpretazioni politiche che mantengono in gran parte tuttora incorrotto il loro valore: pensieri spesso taglienti, in una prosa sempre serrata ed efficace. La quiete della sera, un silenzio interrotto dal fruscio delle dita sulle pagine o dello scorrere di un calamo: un dialogo muto e intenso, in una sorta cittadella – spirituale, ben prima che fisica – che richiama il concetto de «in arce sapientis» su cui si basava il commento ai Sermones di Quinto Orazio, oggetto di una lettura che data ugualmente di molti anni fa.
Uno storico “pompeiano” all’alba dell’Impero
La sempre magistrale interpretazione proposta da Lidia Storoni Mazzolani (rif.: L’impero senza fine, 1972) ci guida nell’analisi dei grandi storici latini: nel grande storico patavino “la «virtus» diventa strumento ideologico”. Questo concetto si presta però a un’interpretazione più vasta: la temperie generale della letteratura augustea, che esprime sollievo e gratitudine verso Ottaviano che ha chiuso il Tempio di Giano dopo un interminabile periodo di guerre civili; la lotta politica che non esiste più, perché è diventata pace. Tito Livio che – pur scrivendo sotto Augusto – era dallo stesso imperatore argutamente definito come storico “pompeiano” (Svetonio, Claudius, XLI; Tacito, Annales, IV, 35), sente la grandezza dell’Impero ma non dimentica gli ideali repubblicani che ne hanno consentito l’edificazione e apprezza il rispetto formale della legalità professato da Augusto.

Il sollievo per una ritrovata pace, che garantisce il rispetto della libertà e del diritto; a un secolo di distanza, di un analogo “sentire” si trova pieno riscontro anche nelle pagine di Cornelio Tacito: il più grande degli storici latini. Nel capitolo III de La Vita di Agricola, opera scritta dopo la fine del terrore di Domiziano (96 d.C.), afferma che “ora finalmente si torna a respirare” («nunc demum redit animus»), grazie ad un imperatore come Marco Cocceio Nerva che ha saputo coniugare cose una volta incompatibili come il principato e la libertà («res olim dissociabiles […] principatum ac libertatem»); la generazione di Cornelio Tacito aveva dovuto attraversare un’epoca – l’ultima parte del regno della dinastia dei Flavi – in cui “la memoria stessa avremmo perso con la voce, se fosse in nostro potere dimenticare come tacere” («memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere» – Agricola, II).
Ma torniamo ancora all’alba del Principato; nella parabola personale – umana, ancora prima che letteraria (ma i due aspetti sono inscindibili) – di Publio Virgilio e Quinto Orazio, i poeti sacerdoti dell’Impero («imperii vates»), c’è il paradigma del percorso spirituale e culturale di una intera generazione di “assi” che popola l’età augustea: la cosiddetta “età dell’oro” della letteratura latina.
Orazio (Epodi, Satire, Odi, Epistole), Virgilio (Catalepton V, Bucoliche, Georgiche, Eneide). Anche questi Autori, prima di arrivare alla «pax augustea», hanno avuto il loro «patriai tempore iniquo»: lo stesso di Tito Lucrezio (I, 49). Un periodo che ne ha condizionato l’evoluzione, da un lato dell’ideale filosofico (il giovane Virgilio alla scuola epicurea di Sirone, a Napoli, che dopo aver lasciato i “vani” studi di retorica scrive nel Catalepton 5: «Ite hinc inanes, ite, rhetorum ampullae») e dall’altro delle scelte politiche: il giovane Orazio che, schierato a Filippi dalla parte dei cesaricidi Bruto e Cassio, scappa dal campo di battaglia buttando via lo scudo per fare più in fretta. Per inciso, come non ripensare allo “scudo abbandonato” di Archiloco?
«ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι, ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων· αὐτὸν δ’ ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.» (Fr. 5 West)
[Si fa bello uno dei Sai dello scudo che vicino a un cespuglio lasciai, ed era non disonoratoǃ, controvogliaː
però mi son salvato. Chi se ne importa di quello scudo? Al diavoloǃ Presto ne comprerò uno non peggiore.]
Nella prima opera di Orazio, gli Epodi, il poeta si ispira stilisticamente proprio ai “duri giambi” di Archiloco: c’è un messaggio di rifiuto degli orrori e del sangue della guerra civile e l’aspirazione a viaggiare alle isole fortunate, oltre il mare (XVI, 39-48); proseguendo nel percorso, pur con le dovute differenze, la gratitudine e il sollievo dell’agricoltore al quale un “dio” ha concesso la pace presente («deus nobis haec otia fecit» – Virgilio, Ecloga I, 6), presenta analogie con il celebre «hoc erat in votis» con cui Orazio inizia la Satira Sesta del II libro.
Tito Livio scrive ugualmente all’alba del Principato: gli oltre 140 libri nei quali si articolava la sua narrazione – che inizia «ab Urbe condita» e terminava con le esequie di Druso caduto in combattimento in terra germanica – sono l’opera di tutta la sua vita; il suo fu “uno stile che nello stesso tempo è eloquenza e poesia” (come lo definì Concetto Marchesi): secondo l’interpretazione di Quintiliano, un carattere proprio dello stile di Livio era una vena facile e feconda («lactea ubertas» – Inst. Orat., I, 32).
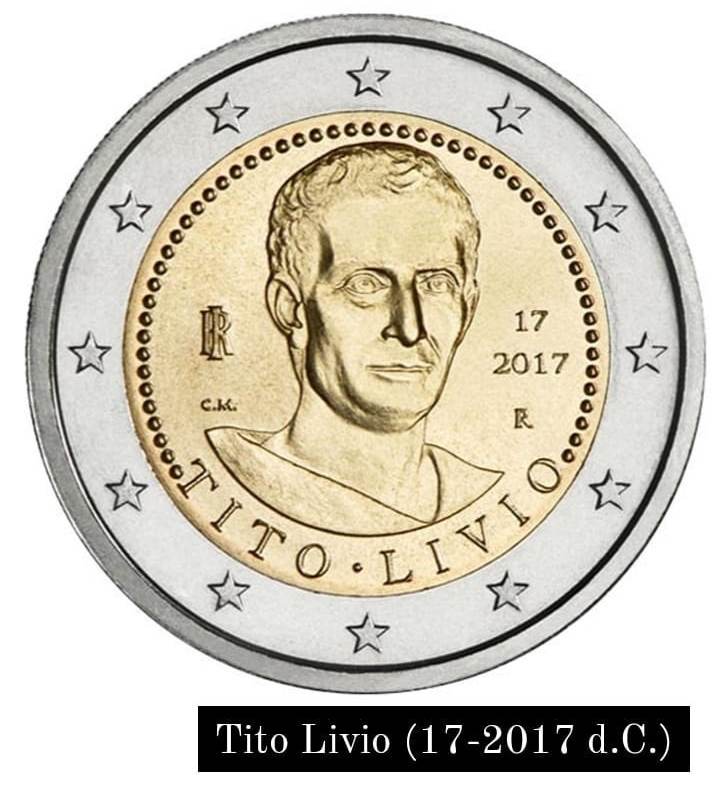
«Ciò che per Lucrezio è la Natura, per Livio è Roma» (Concetto Marchesi)
Una lettura a tratti totalizzante: la sua è una visione quasi religiosa della grandezza e della salvaguardia della «res publica», lo Stato davanti al cui destino scompare l’importanza dei singoli individui: lo spirito della «devotio» dei Decio Mure (Battaglia del Vesuvio – VIII, 9; Battaglia del Sentino – X, 28). Raramente la logica del “per il bene della causa” è stata tratteggiata così compiutamente. Tuttavia, tale concezione viene proposta in una chiave ben più universalizzante, ancora da una nota di Concetto Marchesi: “ciò che per Lucrezio è la Natura, per Livio è Roma”.
Tito Livio vive una sorta di metempsicosi che lo porta a rivivere le epoche della sua patria con la stessa intensità di chi veramente le ha vissute, e conduce magicamente il lettore a percorrere la medesima esperienza. Con la fine della terza decade, che conclude la narrazione della guerra annibalica, dice di sentirsi spossato come se avesse dovuto anche lui aver dovuto guerreggiare attraverso i decenni (XXXI, I, 5): ci ha portato da Sagunto al Trasimeno, tra incendi e cozzare di spade e lance; si è insinuato con noi nelle fini pieghe della psicologia del «Cunctator» Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore. È rimasto accanto a noi – muto, dolorosamente attonito, forse anche incredulo – davanti allo spettacolo da inferno dantesco della piana dell’Ofanto, il giorno successivo alla più cocente disfatta mai patita da un esercito consolare (XXII, 52):
[Il giorno dopo, non appena fu chiaro, si dedicano a raccogliere le spoglie e ad osservare la strage, orribile anche per dei nemici. Tante migliaia di Romani giacevano, fanti e cavalieri qua e là, così come il caso li aveva uniti, ciascuno, o in battaglia o nella fuga; alcuni, mentre si levavano coperti di sangue dal mezzo della strage, perché li avevano destati le ferite inasprite dal freddo del mattino, furono trucidati dai nemici; trovarono alcuni che giacevano con i femori e i garretti recisi, mentre denudavano la nuca e il collo ed invitavano a versare il sangue rimasto; furono trovati alcuni con la testa infilata nella terra scavata ed era evidente che si erano fatti una fossa per sé e affondandovi il viso si erano soffocati con la terra gettata sopra. Attirò particolarmente l’attenzione di tutti un numida, estratto vivo da sotto un romano che gli giaceva sopra, con il naso e le orecchie strappati, poiché, con le mani inservibili ad impugnare un’arma, volta in furia la collera, era spirato dilaniando con i denti il nemico.]
Il testo in latino
‹‹Postero die ubi primum inluxit, ad spolia legenda foedamque etiam hostibus spectandam stragem insistunt. Iacebant tot Romanorum milia, pedites passim equitesque, ut quem cuique fors aut pugna iunxerat aut fuga; adsurgentes quidam ex strage media cruenti, quos stricta matutino frigore excitaverant vulnera, ab hoste oppressi sunt quosdam et iacentes vivos succisis feminibus poplitibusque invenerunt nudantes cervicem iugulumque et reliquum sanguinem iubentes haurire; inventi quidam sunt mersis in effossam terram capitibus quos sibi ipsos fecisse foveas obruentesque ora superiecta humo interclusisse spiritum apparebat. Praecipue convertit omnes subtractus Numida mortuo superincubanti Romano vivus naso auribusque laceratis, cum manibus ad capiendum telum inutilibus, in rabiem ira versa laniando dentibus hostem exspirasset.››
Ci ha infine condotto in terra tunisina, ad assistere al colloquio tra Annibale e Scipione – venato di considerazioni filosofiche sulla labilità dei destini umani a fronte di eventi forse già prefissati ed immutabili nel loro evolvere – alla vigilia dello scontro decisivo nella pianura di Zama (XXX, 30-31).
Ammette infine di essersi sbagliato: pensava che il suo compito di storico sarebbe divenuto via via più agile e scorrevole man mano che si fosse avvicinato nel corso della narrazione alle epoche più recenti; successivamente, ci confessa che sta avvenendo esattamente il contrario: si paragona ad un uomo che si allontani a piedi dalla riva del mare dirigendosi verso il largo: ad ogni passo, nuovi e più complessi orizzonti si aprono – dapprima indistinti e poi più nitidi – nuovi abissi e profondità inesplorate sembrano chiamarci da ogni parte (XXXI, I, 5).
«iam provideo animo, velut qui proximi litoris vadis inducti mare pedibus ingrediuntur, quidquid progredior, in vastiorem me altitudinem ac velut profundum invehi, et crescere paene opus, quod prima quaeque perficiendo minui videbatur.»
[già prevedo con il pensiero, come coloro che messo il piede nei guadi prossimi al lido entrano in mare, che quanto più mi inoltro in tanto più vasto fondo sono balzato, quasi in un abisso, e scorgo tra le mani crescermi il lavoro che nel compiere successivamente le prime parti era parso diminuire]
Riflessioni profonde, che appaiono adattarsi perfettamente a qualunque cimento della mente, della creatività e dell’intelligenza umana: dal campo letterario e artistico a quello tecnico e scientifico.
Prosegue con “Tacito, analisi politica e passione tragica“
Piano dell’opera
- Gaio Sallustio e la concordia perduta
- Tito Livio e la sacralità della “res publica”
- Tacito, analisi politica e passione tragica
- Lucrezio, ragione e angoscia
- Cicerone, tra otium e negotium
- La crisi dell’arte retorica
- Alcuni storici minori
- Petronio, arguzia ed estetica
- “La satira, che è tutta nostra…”
- Lucano, crasi tra epica e storica
- Astrologia, filosofia e magia
- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione
